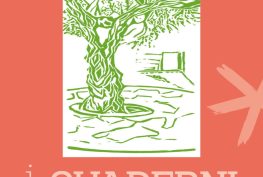Russia 1917-1991
Erica Klein
Laureata in Lingua e Letteratura russa. Traduttrice dal russo di classici. Saggista e autrice di numerosi lavori di critica letteraria.
Nel 1991 si è dissolto dall’interno il regime sovietico uscito dalla rivoluzione del 1917 ed è avvenuto con la stessa stupefacente repentinità con cui 74 anni prima si era volatilizzato l’impero zarista. Tutte e due le volte in pochi giorni, lasciando di stucco i disarmati abitanti del Paese e il resto del mondo. Ma le cose in Russia succedono così, o precipitano o non se ne fa nulla. La gradualità del divenire, almeno nelle sue forme visibili, pare essere estranea alla storia russa, se cambiamento dev’essere, lo sia in maniera radicale. Un’attitudine massimalista che ha sempre disdegnato qualunque tentativo di migliorare l’esistente, per paura forse di far crollare l’intero edificio. E così, imperi che avevano il marchio dell’eternità sono crollati dall’oggi al domani. Delle macerie di quello sovietico parlano i libri di Svetlana Aleksevič, premio Nobel per la letteratura 2015. È andata in giro per la Russia e le altre terre ex-sovietiche di cui lei stessa è stata inquilina, a raccogliere gli umori degli abitanti di un paese scomparso, l’URSS, ad ascoltarne la frustrazione per l’inganno: ci avevano fatto credere che costruivamo il socialismo e ora salta fuori che non è più vero niente, che il capitalismo è meglio, e io cosa me ne faccio ora della mia vita tutta spesa dietro quel progetto e dei miei genitori, nonni, deportati sotto Stalin, tacciati da nemici del popolo? Non era vero niente, lo sapevo, ma il rigore era necessario in quella fase storica, dovevamo proteggerci. Decenni di silenzi (mezzo paese è stato nel gulag, ma in casa non se ne parlava), di paure ingoiate, di fatti non detti che chiedono ora udienza in chi ha la bontà di ascoltare. Perché all’improvviso ci si è accorti di avere storie personali da raccontare, emozioni da lasciar uscire, domande da porsi che non hanno avuto diritto di cittadinanza. Contava sempre solo la Grande Storia, il Grande Ideale, la Grande Rivoluzione, il Grande Lenin, ma come abbiamo fatto a vivere solo storicamente? E si può forse vivere storicamente? Le nostre piccole esistenze di rotelline di un ingranaggio sovrumano valevano zero e il bello era che ci credevamo anche noi e ci sembrava giusto così. Questo esce e tanto altro dalle interviste della Aleksevič, insieme a un gran bisogno di conforto, di denuncia, ma anche di assoluzione, di voglia di non sentirsi colpevoli per non aver visto, capito, ma solo creduto. Tutti vogliono sentirsi soltanto vittime al cospetto di un passato terribile con cui è maledettamente difficile fare i conti. Il risultato è che le chiese prima chiuse o usate per immagazzinare patate ora sono sovraffollate, un intero popolo prova a curarsi così, con la religione, fino a ieri “oppio dei popoli”, oggi unica psicoterapia che ci si concede. Finché c’era il Partito era lui la vera Chiesa, offriva poco per l’anima, non affrontava il problema della morte, della vecchiaia, del senso della nostra piccola vita, ci bastava quello dell’Umanità, ma non ne sentivamo la mancanza, o forse la sentivamo, ma non lo sapevamo. Già, come mai? Vivevamo come in un acquario e oggi ci hanno buttato a riva depredati di tutto, dell’impero, del comunismo, della sicurezza, delle convinzioni e non sappiamo più chi siamo. È come ammettere di aver sbagliato dio.
“In giro, in TV dicono cose terribili, che la Grande Rivoluzione è stata un colpo di stato militare, un complotto bolscevico… una catastrofe e a fare la rivoluzione sono stati disertori e marinai ubriachi. Come si permettono? Il socialismo in generale ci andava bene, non c’era gente esageratamente ricca e gente poverissima senza tetto, né i bambini di strada… I vecchi potevano campare con la pensione senza dover frugare nell’immondizia… volevamo solo un socialismo più mite, più umano. E cosa abbiamo ricevuto? Un capitalismo selvaggio, ma neanche, peggio, gli oligarchi non sono capitalisti, sono semplicemente dei ladri, ladri ex-comunisti che hanno fiutato il vento e hanno rapinato tutto. E allora cos’è servito fare la rivoluzione? Inondare la terra russa di sangue per ritrovarci a questo punto?”.
Sono riflessioni tratte da Tempo di seconda mano, Bompiani, 2013.
Anton Čechov, unico fra i letterati del suo tempo, oltre a Dostoevskij che lo ha preceduto e di cui diremo, non credeva nella Rivoluzione, credeva nello sforzo di ogni singolo individuo per autoperfezionarsi, rendendo così un servigio anche alla società. “Se ognuno nel suo piccolo facesse quello che è in suo potere, ecco che le cose generali andrebbero meglio”, rifletteva. Esattamente quello che nessuno era disposto a fare. L’intellettuale russo di secondo Ottocento soffriva di paralisi della volontà, originata dalla convinzione che nulla si potesse fare di buono individualmente, se prima non si fosse annientato il male sociale. Era un dogma. Male sociale ed esistenziale avevano un’unica origine: l’ambiente corrotto impossibile da riformare. Le opere di Čechov raccontano di questo stato d’animo stagnante, intrappolato nell’inerzia. Il presente non valeva nulla, non era vita, si delegava al futuro. Čechov morì nel 1904 senza assistere, per sua fortuna, a ciò che più di tutto temeva: l’arrivo del Grande Bene, con tutta la “necessaria” violenza che si sarebbe portato dietro.
Sono passati cent’anni da quando la Russia ha tentato l’esperimento sociale che l’umanità sognava da tempo e su cui si era proiettata con esaltazione totale: la costruzione di uno stato comunitario che abolisse una volta per tutte disuguaglianze e privilegi. La rivoluzione del 1917 è stata un mito, uno spartiacque, un gigantesco investimento emotivo di carattere sacro che ha definito i contorni del mondo contemporaneo e solo ora che la sua ombra ha cominciato a ritirarsi si può provare a parlarne in termini più umani. È scoppiata improvvisa, ma ineluttabile, perché infinite circostanze grandi e piccole si sono messe insieme per farla accadere e perché da decenni occupava le menti della intelligencija come fissazione, con tutta la forza messianica che accompagna le idee grandiose. La si invocava da metà Ottocento come panacea di tutti i mali, come rigenerazione del mondo. Bastava abbattere lo zarismo – si diceva – e una civiltà piena di senso e di giustizia sarebbe apparsa per incanto. Le forze creative della parte pensante della nazione si sarebbero unite a quelle vivificanti e genuine del popolo semplice in una nuova grande era di progresso dell’umanità. Accadde qualcosa di diverso: l’idea di giustizia sociale da cui tutto era partito sfuggì di mano e si trasformò rapidamente in rivolta dei servi gonfia di odio e di vendetta. La Russia precipitò nell’anno zero della civiltà travolta dall’immensa marea contadina, incoraggiata nella sua furia iconoclasta dal motto bolscevico: “espropriate gli espropriatori”. Resta da capire perché sia toccato proprio alla Russia mettere in pratica una rivoluzione socialista, al di là di ogni analisi e previsione. Marx l’aveva immaginata in un Paese moderno, fortemente industrializzato, con una robusta classe operaia consapevole della propria forza e dei propri diritti. Forse non è stata nemmeno una rivoluzione socialista, anche se amava chiamarsi tale, ma un’immane sollevazione del mondo rurale contro il latifondo, contro le città, contro la cultura in generale. Bastava portare un paio di occhiali per diventare nemico, per essere ricondotto all’odiata élite che si voleva cacciare dalla Storia. Una élite che, per gran parte, aveva lavorato per la sommossa, non sapendo di tagliare il ramo su cui era seduta. Se l’era immaginata questa rivoluzione in tutt’altro modo, come unione mistica col popolo, come esperimento di palingenesi totale dell’uomo e della società, la famosa parola risanatrice che il mondo aspettava dalla Russia.
La ricerca del regno di Dio è un antico sogno dell’umanità, ma nel pensiero russo aveva assunto proporzioni apocalittiche. Dietro c’era tutta una tradizione escatologica che la Russia aveva già vissuto secoli prima e che ora ritornava sotto altre forme. Con la caduta di Bisanzio, sotto i turchi, Mosca aveva preso in mano il vessillo della cristianità ortodossa ed era rinata, nell’immaginario collettivo, come terza Roma e una quarta non ci sarebbe stata mai. Su questo mito di eternità raggiunta si era costruito il potere sacrale degli zar durante quattrocento anni. Un nuovo progetto di fine della Storia si faceva ora avanti con la Rivoluzione che avrebbe abbattuto per sempre il regno dei soprusi e instaurato il governo universale dei lavoratori. L’utopia è sempre stata in Russia quanto di più concreto si possa immaginare. Nell’Ottocento le idee di importazione occidentale dal Romanticismo all’Hegelismo, al Darwinismo, al Positivismo, al Marxismo erano vissute, di volta in volta, come verità definitive ed era maturata l’urgenza di tradurre una buona volta in realtà soluzioni che non potevano più restare nel solo ambito filosofico. Un’ansia di saltare le tappe attraversava l’intero ceto intellettuale. La Russia era rimasta estranea al processo di secolarizzazione avvenuto in Occidente, non aveva conosciuto i passaggi cruciali della modernità europea, Umanesimo, Rinascimento, Riforma, Illuminismo. Si era sempre mossa a scatti dopo periodi di sonno e con l’impazienza di dover recuperare. Pensò di far tesoro della propria arretratezza, ignorando il passo lento dello sviluppo storico. Anzi era una buona occasione per non permettere al “mostro nascente” della borghesia russa di affermarsi, proprio ora che muoveva i suoi primi decisi passi. Lenin avrebbe fatto proprio e consolidato questo sentimento di avversione a tutto ciò che era borghese, cultura, scienza, libertà costituzionali incluse. Era opinione diffusa del ceto pensante che la Russia non avesse bisogno di Parlamento, di Costituzione, di riforme, ma di qualcosa di più sostanziale, che qui poteva fare di più e meglio dell’Occidente con cui era sempre in antagonismo e competizione. Le battaglie per limitare il potere monarchico, le libertà civili, i diritti della persona erano tutti abbellimenti, chiacchiere che andavano bene per l’Occidente borghese, non erano una priorità per la Russia (avrebbero avuto modo in seguito di ricredersi su questa noncuranza). Il popolo non sapeva che farsene di tutto ciò – si diceva – ma voleva solo uscire dalla miseria con un rivolgimento totale, in preparazione del quale era imperativo mobilitare tutte le energie migliori. Occorre dire che il “popolo” era visto come una sorta di entità metafisica con cui confrontarsi. Forse qui è la radice di tanto di ciò che è successo, la non conoscenza della natura umana, del lato oscuro, selvaggio di chi ha patito secoli di schiavitù. Si parlava senza tregua di popolo, senza averne la più pallida idea. Da quando, verso metà Ottocento, la società si era accorta di queste moltitudini di mužiki alle cui spalle viveva, le aveva trasformate in “popolo” monolitico, dolente, sottomesso, immensamente buono e addirittura depositario di verità autentiche, non deformate da intellettualismi culturali. Non sapeva quanto primitivo e indecifrabile fosse il pensiero delle comunità dei villaggi. È rimasta negli annali l’estate del 1874 che vide brigate di ragazzi della migliore società abbandonare a ondate le prestigiose dimore nobiliari e le frivolezze dei balli per raggiungere, in ruvidi abiti da lavoro, villaggi sperduti della Russia profonda, per portare sostegno. Fu un fiasco completo. I contadini, nel loro mondo chiuso, non volevano saperne di loro, ci vedevano sotto una trappola dei ricchi per incastrarli ulteriormente. Non apprezzavano nemmeno le loro chiacchiere sulla Rivoluzione prossima ventura, erano affezionati allo zar e all’idea monarchica e in generale finivano per denunciare alla polizia, come provocatori, i volonterosi ragazzi. Un’offerta di sacrificio davvero inutile e controproducente che serviva più che altro a loro stessi, al loro bisogno di espiazione, di dedizione assoluta a una Causa in cui perdersi. Contavano inoltre di ricomporre una scissione che pativano interiormente per la grande distanza da quel popolo in cui avevano idealmente collocato le loro radici, la loro identità più profonda. La rottura che Pietro il Grande aveva imposto alla Russia ai primi del Settecento, ordinando alla élite un’europeizzazione forzata e perfino un’altra lingua (i nobili erano obbligati a esprimersi in francese), non era passata indenne e chiedeva da tempo di essere rimarginata. L’incomprensione fra i due mondi cresciuti lontani era totale, la prima di una lunga serie che avrebbe consumato vite e speranze nella vana ricerca di un’utopia da vivere. Popolo e Rivoluzione divennero le parole chiave di cui visse l’intelligencija del secondo Ottocento. L’atmosfera s’impregnò di rifiuto integrale, di disgusto per l’esistente, visto come amorale in attesa dell’agognata armonia che sarebbe scaturita solo da una Rivoluzione. Si negavano le strutture vigenti, cultura compresa, vissuta come menzogna, l’invito era quello di semplificarsi per non accentuare il divario dal popolo (“tutta la poesia di Puškin non vale un paio di stivali” tuonava il critico Pisarev, nella sua Distruzione dell’estetica). Umori che si sarebbero depositati nella coscienza dei rivoluzionari, insieme a istanze di fanatismo estremo. Negli Anni Sessanta aveva cominciato a circolare un libriccino intitolato Il catechismo del rivoluzionario di un tale Sergej Nečaev, discepolo di Bakunin, un breviario spirituale in cui si teorizzava l’obbligo di spogliazione di sé in vista della Causa: il rivoluzionario non doveva avere interessi, né affari, né sentimenti, né legami personali, niente di suo, nemmeno il nome, tutto doveva essere convogliato verso un unico interesse, pensiero, passione: la Rivoluzione. Ciò che serviva la Rivoluzione era morale, tutto il resto ignobile. Alla formulazione teorica dei nuovi valori, Nečaev univa una fervida attività di militante. Divenne capo di un’associazione segreta, la “Narodnaja rasprava” (Giustizia popolare sommaria), denominazione quanto mai profetica, collegata a un’organizzazione che disponeva di una fitta rete di piccole cellule sparse su tutto il territorio, tenute insieme dall’ideologia, dallo spionaggio reciproco e dalla complicità delittuosa, pronte a sollevarsi a un cenno del capo. Questo Nečaev, fra l’altro giovanissimo all’epoca dei fatti, fu poi condannato a vent’anni di lavori forzati in Siberia per assassinio. Uno studente di nome Ivanov era stato rinvenuto in fondo a uno stagno con una pietra al collo per essersi dissociato dalla Causa, come risultò nel corso del processo. Processo che portò alla luce, insieme alla macchinazione, un tale diffuso sistema di infamie, odio e negazione di ogni etica da far rabbrividire l’intera società e soprattutto l’opinione pubblica progressista che si sentì chiamata in causa e si affrettò a dissociarsi da ogni possibile parentela. Testimone d’eccezione dell’intero processo fu Fëdor Dostoevskij che conosceva per vie indirette il ragazzo ucciso e traspose l’intera vicenda e le sue tenebrose implicazioni psicologiche nel celebre romanzo I demoni, dove Ivanov comparve sotto il nome di Šatov. Nello scatenamento rivoluzionario che si andava prefigurando egli vide all’opera una fenomenologia occulta del male che non c’entrava niente con l’uomo come lo conosciamo, ma con il mondo sotterraneo di fantasie patologiche che esiste sempre in qualche forma e talvolta diventa potere politico e cambia il corso della storia. Dostoevskij si rese conto di una realtà psicoanalitica a cui nessuno aveva prestato attenzione, che quanto più sublime è l’ideale che si persegue, tanto più densa l’ombra che si porta dietro. Mentre si puntava all’età dell’oro, si lastricava la strada per l’inferno. Il romanzo non piacque al suo apparire, fu visto come conferma dell’inclinazione malata dell’autore, salvo poi riscoprirlo decenni dopo, a tragedie avvenute, quando divenne chiara la portata delle sue intuizioni. Ciò che inquietava Dostoevskij era la sostanza morale del pensiero rivoluzionario in cui non ravvisava tanto la volontà di rimediare a un abissale squilibrio sociale, quanto un progetto inaudito di riconversione della natura umana in qualcosa di diverso. Se l’individualità umana era prodotta unicamente dall’ambiente, e di questo nessun rivoluzionario dubitava minimamente, lo confermavano del resto le scoperte delle nuove scienze, bastava esporla a un ambiente rinnovato e corretto per riprogrammarne i codici psichici e di comportamento. Si trattava di rovesciare le vecchie strutture e sovrastrutture in fatto di cultura, etica, religione, simboli e imporne di nuove, adeguate alla sterzata in senso egualitario che si voleva imprimere alla società. Sarebbe venuto alla luce un nuovo tipo di uomo, razionale, disciplinato, collettivo, predisposto a interessi comunitari e non a quelli egoistici, di parte. Certo sarebbe stato necessario mettere in campo una gran dose di violenza per spazzare via il vecchiume, ma questo non era un problema, se la meta era quella radiosa di rifondare la convivenza secondo nuovi principi, nuovi valori, nuovi dei. Trockij non si farà scrupoli ad affermare la necessità di “farla finita con i vaneggiamenti quacchero-papisti sulla santità della vita umana”. La questione dei risvolti etici del conflitto rivoluzionario attraversa un po’ tutti i romanzi di Dostoevskij e si condensa in quel “tutto è lecito” se il fine è nobile a cui si inchinano alcuni suoi grandi personaggi, da Raskol’nikov a Ivan Karamazov. Ma se la vita del singolo individuo non è più criterio morale assoluto – si tormentava Dostoevskij –, se lo è invece l’idea di cui l’uomo diventa ostaggio, la strada che si apre porta diritto alla follia e alla mattanza senza fine. Il grande conflitto ideologico dentro il pensiero rivoluzionario fra libertà individuale e uguaglianza sociale, che sarebbe diventato cruciale nelle società comuniste sembrava un non problema. Ma si sa, sulla carta le teorie funzionano, sono chiare e comprensibili, mentre la vita è caotica, piena di assurdità e di incongruenze e alla lunga finisce per scompaginare le concezioni troppo elementari e unilaterali.
Un primo sentore del fatto che ci si era spinti troppo in là e che poteva succedere l’irreparabile si ebbe nel 1905, quando la teoria incontrò effettivamente la pratica. Furono le prove generali del 1917, ci si accorse allora che l’Ottocento era davvero finito, che un nuovo secolo pieno di moderne potenzialità chiamava all’appello anche la Russia. L’anno era cominciato male, con la prima fatale rottura di un’alleanza secolare, quella fra lo zar batjuška (lo zar padre) e il suo popolo. C’è una data precisa di quella frattura, il 9 gennaio. La giornata era di sole, ma ugualmente gelida, quando un corteo di oltre 150.000 persone si mosse dai quartieri operai di Pietroburgo verso il centro con una supplica per lo zar. I dimostranti affamati chiedevano sollievo alla miseria che si era aggravata con la disgraziata guerra al Giappone. Più che una protesta pareva una processione, guidata com’era da un prete, il pope Georgij Gapon, e colorata di icone, stendardi imperiali, ritratti di Nicola II, sotto l’inno: “Dio salvi lo zar”. Ma ad accoglierli davanti al Palazzo d’Inverno non c’era lo zar, già fuggito nella residenza fuori città, ma un plotone che non esitò a sparare sulla folla. Fu una carneficina con migliaia di morti che indignò l’opinione pubblica di tutta la Russia e ridiede fiato alla sinistra più estrema rimasta un po’ appannata negli ultimi tempi. Si depositò inoltre nella coscienza nazionale come la domenica di sangue gravida di conseguenze. Quando nel settembre di quello stesso anno arrivò nelle campagne l’eco di quanto era successo nella capitale si scatenò un inferno distruttivo che travolse, incendiò, massacrò tutto ciò che era a portata di mano. Quel 1905 fu decisivo per la fine delle illusioni, delle fantasie, della cecità. Divenne chiaro che la tanto agognata Rivoluzione, qualora fosse davvero divampata su scala nazionale non avrebbe portato a un nuovo fertile umanesimo in Russia, ma alla sua distruzione. Divenne altresì chiaro che la monarchia irrigidita nella fissità autocratica non aveva la forza, né l’intuizione per cogliere il rombo che saliva pauroso dai sotterranei dell’immenso paese. Lo capirono invece le città, le due grandi capitali, Mosca e Pietroburgo che stavano vivendo dai primi del Novecento una fase di sviluppo senza precedenti. Fu allora che il ceto urbano volse definitivamente le spalle sia alla mistica contadina che allo zarismo vecchio stile. Se la monarchia era immobile, chiusa nei suoi riti, la società era andata avanti per conto proprio. Insieme all’esordio dell’industria, del grande capitale, delle banche, delle associazioni professionali si era fatta avanti una giovane borghesia liberale ansiosa di riforme, di nuove istituzioni, di Parlamento, di diritti, per mettersi alla pari con le democrazie occidentali. Pietroburgo era semplicemente magnifica, elegante, scintillante di vetrine, di ristoranti, di librerie, di teatri. Era esplosa una vita culturale non diversa da Berlino e da Vienna. La città si era stancata di naturalismo, positivismo, dell’intossicazione ideologica e improvvisamente aveva preso coscienza della propria bellezza senza sensi di colpa. Voleva vivere tutte le esperienze artistiche del mondo, aprirsi a ogni modernità. Finalmente poteva permettersi di ammirare i “pesci rossi” di Matisse per quello che erano, senza doverli accusare di non rappresentare le masse diseredate, come da alcune parti si ingiungeva. Artisti, filosofi, poeti, architetti, scenografi (i favolosi balletti russi di Djagilev nacquero allora) si affrettarono in quel breve, intenso, Rinascimento russo a dire la loro prima della fine, nell’oscuro presentimento che quella civiltà di cui solo ora si percepiva la grandezza, sarebbe presto sprofondata. Gli anni dal 1905 al 1914 furono, nella loro incertezza, gli ultimi tranquilli del vecchio mondo. Poi la guerra. Scoppiò improvvisa nell’estate del 1914 “l’aspettavamo tutti e nessuno ci credeva”, commentò anni dopo lo scrittore Viktor Šklovskij.
Come dovunque in Europa l’ondata di emozioni patriottiche contagiò anche le menti più lucide. In Russia, per l’ultima volta, il popolo si strinse intorno allo zar che, nell’immaginario, divenne il protettore di tutti gli slavi. L’odio collettivo s’incanalò verso tutto ciò che era tedesco, distogliendo momentaneamente lo sguardo dai conflitti sociali. Furono presi di mira proprietari tedeschi, commessi tedeschi, funzionari tedeschi, tutto ciò che suonava teutonico, perfino la capitale mutò il proprio nome in ossequio alla nuova direzione del vento, divenne Pietrogrado, versione slava di Pietroburgo. Alla morte di Lenin e in suo onore, nel 1924, cambierà un’altra volta nome, diventando Leningrado, per ridiventare Pietroburgo, anzi, San Pietroburgo col crollo del regime sovietico e a conclusione di un referendum popolare tenuto nel 1991.
La tanto attesa Rivoluzione, quella fantasticata da tutto l’Ottocento, arrivò di soppiatto, senza enfasi, davvero una figura di leggenda, all’inizio nemmeno riconosciuta. Si presentò nel bel mezzo di una coda per il pane. Era il 23 febbraio corrispondente all’8 marzo del calendario occidentale, la giornata delle donne. E difatti furono le donne, le operaie tessili del sobborgo di Vyborg, dopo ore e ore in fila al gelo davanti a un fornaio, a mettersi in moto. Si era alla fine del terzo anno di guerra e mancava tutto, niente carburante, niente farina, niente trasporti. Dopo turni di dieci ore le donne si mettevano in coda con sgabelli in attesa della distribuzione di pane e zucchero, a volte si portavano dietro perfino le brande, per non perdere il primo turno davanti alle botteghe e pernottavano lì. Il morale del Paese era a pezzi, la guerra, che nelle intenzioni dei vertici doveva durare sei mesi si trascinava drammaticamente con un milione e ottocentomila tra morti e feriti solo nel primo anno, la corte era non soltanto screditata, ma demonizzata per via della zarina di nazionalità tedesca, accusata di combutta col nemico, lo zar, freddo, distante, insensibile. Di Nicola II si può dire che non è mai stato all’altezza di niente. Del resto non gli importava di essere zar, non avrebbe voluto esserlo, ma dato che il destino lo aveva depositato lì, si era dato un’unica missione nella vita: trasmettere il trono intatto, così come l’aveva ricevuto da suo padre, al figlioletto Alessio, per altro molto ammalato. Anzi proprio l’emofilia del bambino avrebbe causato ulteriori scossoni alla corona per via di Rasputin, il diabolico monaco guaritore che, protetto dalla zarina, faceva il bello e il cattivo tempo a corte, fra un’orgia e l’altra sceglieva e licenziava ministri negli anni di guerra, suscitando vergogna e indignazione. Ventidue anni di regno, i più difficili di sempre della Russia, in cui tutto cospirava contro tutto, la rivoluzione ruggiva, la borghesia chiedeva uno straccio di Costituzione e Nicola non si accorgeva di nulla, concedeva qualcosa ogni tanto, poi subito ritirava appena le acque si calmavano, come avvenne con la crisi del 1905. Sordo, ostinato, spaventato, superstizioso, non capiva mai dove si trovava, né cosa si muoveva oltre la sua finestra. Per lui era più facile abdicare che diventare re costituzionale; fu quello che fece alla fine, costretto, ma anche qui arrivò tardi, quando la partita era ormai persa. Un’ignavia che si trasformò in tragedia, sua, della sua famiglia, del suo popolo. Per una questione di coscienza diceva: “Ho giurato per l’autocrazia, devo trasmettere questo giuramento a mio figlio nella sua integrità”. Non poteva ospitare altro dentro di sé. Paradossalmente si sentì più a suo agio quando fu fatto prigioniero dai bolscevichi e portato insieme alla famiglia a Ekaterinburg, quasi 2000 km da Pietroburgo. Lì si sentì finalmente sollevato da ogni peso, sereno, libero di occuparsi delle minuzie domestiche cui era affezionato. È stato l’uomo sbagliato, nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Oggi è venerato in Russia come un santo martire per la fine che gli hanno fatto fare. Nel 1918, nella notte fra il 17 e il 18 luglio fu assassinato per ordine di Lenin, insieme alla moglie, alle quattro figlie e allo zarevič (il piccolo erede), al medico e alle altre persone del seguito. Un plotone d’esecuzione sparò a tutti a bruciapelo, dopo averli radunati, ignari, in un locale della casa. Questo affinché non si potesse tornare indietro. Se la Rivoluzione doveva vivere per sempre, bisognava che il simbolo per eccellenza della vecchia Russia fosse cancellato. Prima di essere sepolti fu versato dell’acido solforico sui loro volti, in modo da impedire ogni riconoscimento. Precauzione inutile, perché le sepolture furono scoperte dopo la caduta del regime sovietico e l’esame del DNA sulle ossa portate in Gran Bretagna stabilirono senza ombra di dubbio l’appartenenza dei resti.
Ma torniamo a quel 23 febbraio/8marzo del 1917, quando le cose si misero a correre là dove la valanga partita le spingeva. Le operaie tessili scesero in sciopero al grido di “Pane! Pane!”. E si trascinarono dietro gli operai delle officine metallurgiche. Il corteo iniziale di 100.000 persone andò ingrossandosi a ogni strada, accogliendo gente d’ogni tipo, fino a diventare una marea gigantesca, inarrestabile. Gli slogan di partenza: “Pane! Pane!” si mutarono in: “Abbasso lo zar! Abbasso la guerra!”. La guardia a cavallo, quella che dodici anni prima, nella domenica di sangue, aveva attaccato la folla rimase paralizzata davanti all’enormità di quello che stava succedendo. Era la Rivoluzione, quella vera, eroica, mai vista, cui parteciparono tutti, operai, soldati, intellettuali, bottegai uniti da un sentimento antimonarchico più forte di qualunque divisione e paura. Le statue zariste prese d’assalto caddero sbriciolate, mentre tutte le istituzioni ch’erano state di sostegno allo zarismo crollarono dalla sera alla mattina: burocrazia, polizia, forze armate, chiesa. Il sentire comune era di onnipotenza e di incredulità. Il potere politico cadde nelle mani di un governo provvisorio liberal-democratico intenzionato a seguire una linea di riforme e legalità. I problemi da affrontare erano giganteschi: approvvigionamenti, guerra, riforma agraria, nuova forma di governo, Assemblea costituente. Il principe L’vov, nominato presidente del governo provvisorio, era un uomo illuminato e democratico, rappresentante di quella società civile che s’era andata formando a fine Ottocento. Varò alla svelta una serie stupefacente di riforme politiche: libertà di riunione, di parola, di stampa, abolizione di ogni discriminazione di religione, razza, classe, della pena di morte, introduzione del suffragio universale, di organi di autogoverno locale. Da un giorno all’altro la Russia si era trasformata nel paese più libero del mondo. Non sembrava vero. E lo fu per un tempo molto breve. Tutto era avvenuto mentre i dirigenti bolscevichi erano lontani, chi in esilio, chi all’estero, come Trockij (a New York) e Lenin (a Zurigo). La fase gloriosa e perfino allegra della rivoluzione aveva i giorni contati. La notizia della defenestrazione dello zar arrivò alle trincee del fronte, alle campagne sterminate, segnò un “liberi tutti” difficile da contenere: un milione di soldati disertò per raggiungere i villaggi, dove ci si aspettava di ricevere le terre dei latifondi espropriati. Col suo ritorno in Russia in aprile, nel famoso vagone piombato dei tedeschi (che certo contavano sulla rivoluzione russa per indebolire il fronte orientale della guerra) Lenin prese in mano la situazione e, senza tanti complimenti, spinse sull’acceleratore di una nuova fase della rivoluzione, quella di ottobre, più consona ai suoi progetti. Il 25 ottobre i bolscevichi entrarono nel Palazzo d’Inverno, arrestarono i ministri del governo provvisorio, diedero vita al nuovo governo chiamato “soviet dei commissari del popolo”. Nemmeno Lenin, professionista della rivoluzione, con un programma massimalista poteva prevedere che in quelle giornate d’autunno si stava realizzando l’evento più straordinario del Novecento, che avrebbe modificato radicalmente la nazione più grande della terra (il suo territorio era il triplo degli Stati Uniti) e dato inizio a una catena di grandiosi cambiamenti sociali e conflitti in luoghi lontanissimi da quella piazza innevata. Né lui, né i suoi immaginavano di poter conservare quel potere che inaspettatamente era finito nelle loro mani. Il neo commissario Lunačarskij commentò in quell’occasione che con ogni probabilità i bolscevichi se ne sarebbero stati lì un paio di settimane per poi essere impiccati a quei balconi. Ci rimasero fino al 1991, anche se non in quel palazzo, ma a Mosca.
La vita nella Pietrogrado bolscevica piombò nel caos con folle inferocite che saccheggiavano magazzini e depositi alcolici. Divenne chiaro a tutti molto preso, dopo poche settimane, addirittura dopo pochi giorni, quello che si era perso, che il nuovo regime avrebbe tolto ogni straccio di libertà, di vita privata, di libero pensiero; tutto doveva piacere al Partito. Il cerchio della storia russa si stava chiudendo. Un’altra vita completamente sconosciuta, con altri rapporti, altri parametri, stava salendo alla ribalta. Non c’era tempo da perdere in capziosità parlamentari e diritti democratici, la vera democrazia era la presa di potere da parte di proletari e contadini poveri rappresentati dal Partito bolscevico; menševichi, socialisti e quant’altro erano fuori. Punto. Per difendere il perimetro di tale scelta ideologica fu fondata da subito una polizia politica dai poteri illimitati, la temuta Čeka, che sarebbe diventata NKVD e poi KGB rimanendo sempre la stessa cosa: organo di vigilanza perenne sulla vita privata dei cittadini allo scopo di individuare sabotatori, speculatori, traditori, nemici del popolo. I quali non sarebbero mancati mai, veri o presunti che fossero. Il primo capo della Čeka fu Feliks Džeržinskij, il cui nome incute terrore ancora oggi ai figli dei figli, ai nipoti di quell’epoca drammatica. Era un rivoluzionario di origine polacca che aveva passato metà della sua vita nelle carceri zariste e che si mise d’impegno a infliggere alle sue vittime le stesse crudeltà che aveva personalmente sperimentato. Non aveva torto Flaubert nell’affermare che in ogni rivoluzionario si nasconde un gendarme. Uno degli aspetti più terribili del terrore rosso che si scatenò subito dopo la presa di potere bolscevico fu la sua casualità. La responsabilità individuale era infatti diventata obsoleta, ciò che contava davvero nell’ottica della giustizia rivoluzionaria era la classe di appartenenza, fattore decisivo per stabilire la colpevolezza dell’imputato. E così finirono nei guai esponenti di tutti gli strati sociali che non fossero proletariato. Ogni altra appartenenza, compresi gli intellettuali che avevano optato per la rivoluzione fin dall’infanzia, finì ai margini, perseguitata o espulsa. Lenin del resto odiava l’intelligencija “bavosamente liberale”, come la definiva, benché egli stesso provenisse dal ceto aristocratico intellettuale. Non sopportava l’idea stessa di critica, perché la critica non era altro che tradimento. La dottrina marxista cui faceva riferimento non era un’opinione, ma una scienza e alla scienza non c’era nulla da controbattere. Chi aveva respirato aria di individualismo borghese era elemento indifendibile, qualcosa di impuro, non poteva essere redento, ma solo espulso. La borghesia come classe stava per uscire dalla Storia, superata dal proletariato, lo diceva la teoria inconfutabile del determinismo storico, anche i contadini sarebbero diventati proletariato, quindi non c’era niente di male a darle una spinta, in senso sia simbolico che fisico. L’intolleranza era arrivata al potere, ma la posta in gioco era troppo alta per qualunque cedimento. Iniziò una guerra su due fronti: quella armata per sconfiggere le forze controrivoluzionarie, i bianchi, su tutto il territorio e quella interna contro una mentalità che non doveva più esistere. Il partito bolscevico le vinse entrambe, ma a caro prezzo. La Russia uscì sfigurata, le vittime di quei primi anni si calcola siano state sui dieci milioni, le città si oscurarono, il livello di vita regredì all’età della pietra. Individuo e società divennero nemici, senza possibilità di incontrarsi. Oggi, in Russia si parla tranquillamente di blocco della modernità imposto al Paese.
Il 16 marzo 1918 il governo trasferì la capitale della repubblica sovietica a Mosca. Più lontana dai confini pericolosi, ma anche meno odiosa di Pietrogrado, così piena di simboli che si volevano ripudiare. Come Pietro il Grande rompendo con Mosca nei primi del Settecento aveva cominciato da capo la storia della Russia, così Lenin, lasciandosi alle spalle la capitale zarista, affermò il diritto a compiere un esperimento radicale. La città, abbandonata a se stessa, negli anni 1917-1918 moriva di freddo e di fame, si bruciavano mobili e libri per scaldarsi, la grande poetessa Anna Achmatova, che divenne poi la voce della Russia muta, ricorda: “Le vecchie insegne pietroburghesi erano ancora al loro posto, ma dietro, oltre alla polvere, alle tenebre, al vuoto, non c’era nulla: tifo, fame, fucilazioni, buio negli appartamenti, persone gonfie, irriconoscibili”. A presidiare i diritti della civiltà, a Pietrogrado era rimasto Maxim Gor’kij, amico di vecchia data di Lenin e soprattutto unico fra gli scrittori ad avere origini proletarie, quindi immune dal peccato originale della provenienza borghese. Questo gli permise di ritagliarsi una posizione unica all’interno del regime, di salvataggio dei perseguitati e di indignazione esplicita per la rozzezza dei nuovi padroni. Come tanti era stato un sognatore umanista della Rivoluzione, per essa si era speso, aveva raccolto finanziamenti in tutto il mondo, la sua fama ai primi del Novecento era immensa ovunque, poteva quindi permettersi ciò che a nessun altro era concesso, anche di esprimere giudizi irriverenti. Accusava senza inibizioni Lenin e i dirigenti bolscevichi di essere “incendiari che stavano compiendo un esperimento crudele di ingegneria sociale sulla pelle del popolo russo”, li rimproverava di essere “già intossicati dal veleno del potere, di avere un atteggiamento vergognoso nei confronti della libertà di parola, di tutti i diritti della persona… la vita nella sua complessità è sconosciuta a Lenin, egli ignora il popolo, le masse, non ha mai vissuto con esse, ma ha appreso dai libri come sollevarlo e scatenarne gli istinti”. Tutto ciò compariva sul giornale Novaja žizn’(La nuova vita) negli anni 1917-1918 dove i suoi settantanove articoli presero il nome di Pensieri intempestivi e naturalmente rimasero occultati per decenni. Fino al 1991, quando si aprirono gli archivi di Stato, e dalla canonizzazione si scongelò un mondo, uscirono persone vive, drammi, insieme a una gran massa di documenti, lettere piene di tensione, protesta, disperazione: “In Russia il cervello è dono raro, possediamo pochi talenti e molti furfanti, canaglie, avventurieri, sterminare uomini di scienza affamandoli o gettandoli in prigione non è opera utile, ma barbarie”. Al che Lenin rispondeva: “È una vergogna sprecare le proprie energie sulla sorte di questo marciume intellettuale…”. Tutto ciò non poteva durare a lungo, il giornale fu chiuso nel 1918 e Gor’kij gentilmente invitato a cambiare aria, ufficialmente per curare una vecchia malattia polmonare. Si stabilì in Italia, a Sorrento, dove trascorse i pochi anni felici della sua vita, finché Stalin lo fece tornare in Russia come cimelio da esibire, salvo poi farlo assassinare nel 1936, probabilmente col veleno e organizzargli funerali faraonici per impressionare il popolo. Ma qui siamo già nel regno della doppiezza di Stalin che inquinerà la Russia obbligandola a entrare nel circuito della sua personale paranoia.
L’epoca di Lenin non durò a lungo, fu quella della guerra civile, del comunismo di guerra, della difesa del nuovo corso. Il nuovo Stato di tipo confessionale con un’unica verità ammessa aveva già messo radici. La battaglia per la conquista dell’anima umana procedeva spedita. Accanto a un ateismo militante si cercava di promuovere un nuovo sistema di simboli con cui rinominare il mondo. Il Partito era la nuova chiesa, il Proletariato la nuova umanità redenta, gli scritti di Marx, Engels, Lenin i nuovi testi sacri. Fu introdotta la festa dell’elettricità e i bambini non più battezzati, ma ottobrizzati davanti a un ritratto di Lenin. Comparvero nomi stravaganti, ricavati da iniziali dei nuovi idoli: Marlen (da Marx-Lenin), Melor (da Marx, Engels, Lenin, Ottobre, Rivoluzione), per le bambine: Ninel’, anagramma di Lenin, Oktobrina, Terrora. Al contempo furono messi all’indice autori che potevano indurre al sentimento religioso, quindi espulsi dalle biblioteche: Platone, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Tolstoj insieme a molti altri; vietato Bach, il Requiem di Mozart, I Vespri di Rachmaninov, ecc. Nessuna Bibbia sarebbe più entrata in URSS. Il sogno utopistico di rimodellare la psiche umana si tradusse in ossessione del dover essere delle cose e quindi del controllo capillare del pensiero. Sul piano economico s’impose l’avversione al mercato, a qualunque tipo di mercato, anche a quello dei “fagottari” che, in periodo di guerra civile, facevano sui treni la spola fra città e campagne. Il mercato era sempre e comunque sfruttamento, rapina, speculazione, avrebbe provveduto lo Stato a farsi carico di ogni bisogno e a distribuire. Scomparvero botteghe, taverne e ogni tipo di servizio dove si praticasse il commercio. Nel 1921 Lenin dovette cedere su questo punto, pena rivolte ingestibili dei contadini che, requisiti di tutto, negli anni della guerra civile per far fronte alla fame delle città, si erano fatti minacciosi. Con la NEP (nuova politica economica) la guerra alle campagne s’interruppe momentaneamente, sarebbe ripresa con Stalin a fine Anni Venti con l’avvio della collettivizzazione forzata.
Lenin morì nel 1924 di colpo apoplettico, mentre era già da tempo invalido, senza parola e sulla sedia a rotelle. Pare che l’eredità del Partito lo inquietasse oltre misura e solo all’ultimo avesse compreso la pericolosità di Stalin e dell’enorme potere che aveva accumulato nelle sue mani. Lo testimonia il famoso testamento tenuto opportunamente celato, ma che per un periodo circolò in clandestinità. Sempre nel testamento chiedeva anche di essere sepolto accanto alla madre, a Pietrogrado. Fu imbalsamato e sistemato sulla Piazza Rossa dove giace tutt’ora. L’idea era stata di Stalin per innescare un culto di indubbio consenso. Conosceva in profondità la psiche del popolo semplice e la sua secolare passione per le sante reliquie. La suggestione gli venne dal ritrovamento avvenuto proprio allora della tomba di Tutankhamon e delle tecniche di conservazione del corpo.
Quando si guarda agli Anni Trenta viene in mente il Cinquecento, un po’ quello russo di Ivan il Terribile, un po’ quello spagnolo dell’Inquisizione. Anche qui i colpevoli dovevano confessare sotto tortura cose che non avevano commesso, ma che gli accusatori volevano sentire. Stalin esigeva la confessione dei suoi prigionieri importanti, soprattutto vecchi compagni di Partito, di essere spie, traditori, sabotatori dello Stato comunista. Gli tornava utile smascherarli, innanzitutto per sbalordire la nazione, prendersi il merito di aver saputo vedere là dov’era impensabile, quindi accreditarsi come padre sempre vigile in difesa della Rivoluzione, in più si prendeva la soddisfazione di vendicarsi dei bolscevichi per non averlo in passato apprezzato, per averlo considerato un provinciale, un incolto, per avergli riservato un ruolo di secondo piano nella Rivoluzione e nella costituzione del nuovo governo, dove fu nominato quindicesimo e ultimo. I processi spettacolari che si celebrarono a Mosca negli anni 1937-1938 avevano un effetto ipnotico sul popolo, fornivano inoltre al proletariato un ottimo bersaglio per un nemico visibile contro cui scagliare la propria ira per l’assillante penuria di generi alimentari. La collettivizzazione forzata dei primi Anni Trenta era stata un indicibile massacro di contadini con milioni di deportati, ma un fiasco dal punto di vista produttivo. Più complicato è capire come i misfatti grossolani di cui si autoaccusavano gli imputati a testa bassa fossero accettati nel resto del mondo. Gli intellettuali d’Occidente che certo avevano tutti gli strumenti per valutare (giornalisti stranieri erano anche stati invitati ad assistere) prestarono fede in massa, tranne poche eccezioni, Albert Camus fra loro, alla versione ufficiale del regime. In quelle occasioni e in tutte le altre. Per una forma di incantesimo o di sudditanza psicologica o vulnerabilità della mente alla seduzione di dottrine socioeconomiche che vedevano nell’esistenza stessa dell’URSS una realizzazione del materialismo dialettico. O semplicemente si credeva, perché la realtà vera era troppo paradossale e incredibile. Al grande equivoco, e alla deformazione che il Metodo provocava nei singoli, ha dedicato profonde riflessioni il noto scrittore polacco Czeslaw Milosz, premio Nobel 1980 in un lavoro del 1953, intitolato appunto La mente prigioniera. Il fatto è che si era entrati in una zona in cui il concetto di vero e falso in senso tradizionale non era più riconoscibile. Il sistema Nečaev di ottocentesca memoria aveva trovato moderna applicazione. Gli sfortunati cittadini di quell’epoca inquietante per provare a stare a galla non potevano non mentire, ma bisognava anche capire il come e il quando della menzogna giusta. Un dispendio enorme di energie. La vita era sempre in bilico, una parola fuori posto poteva costare l’arresto, si copriva il telefono con un cuscino, per neutralizzare le microspie sempre in azione, la delazione era innalzata a virtù, ci si teneva d’occhio a vicenda, la sorveglianza era continua e reciproca, spesso si denunciava per non venire denunciati. Il regime coltivava tutto ciò che di abietto è nella natura umana, legittimato a manifestarsi sotto la copertura di grandiose parole d’ordine. Nessuno si fidava di nessuno, ogni conoscente era un potenziale informatore della polizia, ogni tipo di cordialità fra le persone scomparso, sostituito dal sospetto, chiunque domani o dopodomani poteva essere dichiarato nemico del popolo e chi l’aveva conosciuto chiamato a risponderne; meglio non frequentare nessuno, tutte le strade portavano al lager. Anche se le precauzioni potevano non bastare, nel 1937, ma questo si seppe molto dopo, c’era un piano del Partito che fissava le quote per territorio dei nemici del popolo da smascherare. Forse serviva per procurarsi mano d’opera gratuita (le grandi opere, dal canale del Mar Bianco alla metropolitana di Mosca, furono realizzate da forzati) o per tenere sotto pressione la società, disorientandola con la paura e l’insicurezza, o tutt’e due le cose. Si viveva in un mondo parallelo, di cui si cercava a tentoni di capire la logica. Di giorno si faceva finta di niente, di non accorgersi della realtà, di notte nessuno dormiva con l’orecchio attento al rumore del motore, se per caso il “corvo nero”, la macchina della polizia, si fermava al tuo portone. Poi c’era l’incubo dell’ascensore, a quale piano si sarebbe fermato. Il violinista David Ojstrach a Mosca aspettava l’arresto, forse perché sotto tiro erano finiti i musicisti o perché era ebreo e quindi “cosmopolita”, non lo sapeva. Raccontò poi a Šostakovič (il quale, in attesa lui stesso di arresto per via di una sua opera che non era piaciuta a Stalin, aveva dormito sul pianerottolo tutto vestito per dieci giorni, vicino all’ascensore) che “notte dopo notte, la polizia era venuta a prendere qualcuno nel suo condominio. Mai una retata, una sola vittima per volta, e un’altra la notte successiva; un sistema che accresceva la paura di chi rimaneva. Alla fine erano spariti tutti, tranne gli inquilini del suo appartamento (viveva in coabitazione come i tre quarti dei cittadini) e di quello di fronte. La notte dopo si presentò il camion della polizia: sentirono in strada sbattere le portiere e i passi avvicinarsi in corridoio e fermarsi davanti all’altro alloggio. Da quel momento – gli disse Ojstrach – non aveva più smesso di aver paura “e non avrebbe più smesso per tutta la vita” (da Il rumore del tempo di Julian Barnes). La gente aspettava il proprio turno e intanto doveva fingere ottimismo, più il Paese sprofondava nella cupezza, più era d’obbligo l’allegria, bisognava dimostrare di essere felici di vivere nel migliore dei mondi possibili. Se un uomo veniva arrestato come nemico del popolo tutta la famiglia cadeva in disgrazia, come in una faida tribale, e tutti quello che l’avevano incontrato erano in pericolo. La colpevolezza della moglie era automatica, perché se non aveva denunciato il marito ne era complice. Per i figli esistevano appositi orfanotrofi gestiti dall’NKVD. Furono milioni, derubati di tutto, anche della loro identità, senza poter mai risalire ai certificati di nascita, nel caso riuscissero a sopravvivere. C’era poi una legge del 1935 che abbassava a dodici anni l’età in cui si era penalmente perseguibili. L’incubo di venire arrestati si amplificava per la sorte che sarebbe toccata ai figli. Nel 2002 è stato pubblicato a Mosca un enorme volume: Deti Gulaga (I bambini del Gulag), tradotto anche in inglese l’anno scorso (Children of the Gulag, Yale University Press) che non è un romanzo, solo una raccolta di documenti, pezze burocratiche ufficiali, spezzoni di memorie di bambini che avevano pochi anni all’epoca dei fatti. Niente effetti speciali, solo aridi fatti, letture terrificanti. Si credeva di sapere tutto sui lager, ma non è mai finita. La stima prudente fatta da Aleksandr Jakovlev, Presidente della Commissione del Cremlino per la riabilitazione delle vittime della repressione politica è di venti-venticinque milioni di persone nell’intera era sovietica e di dieci milioni di piccoli “nemici del popolo”. L’Associazione Memorial continua a darsi da fare, fra mille difficoltà, per tutte le vittime, anche straniere, anche italiane, per un motivo o per l’altro inghiottite dal Gulag. L’intento è ricostruire la storia di ognuno di loro, o quantomeno recuperarne il nome.
Stalin ha governato un quarto di secolo, ma in Russia non c’è stata nessuna Norimberga per i suoi crimini. La sua impunità è totale, protetta dalla mistificazione dell’epoca, in patria e all’estero. La guerra contro i nazisti è stata vinta dal popolo russo con enormi perdite e sacrifici, nonostante Stalin, nonostante le purghe, che negli Anni Trenta avevano decimato esercito e marina privandole degli uomini migliori, generali, ufficiali, ingegneri specializzati, ritardando la formazione di una solida difesa sovietica. Ludmila Aleksevič scrive: “Stalin non si finisce più di seppellirlo, ma non si riuscirà mai a seppellirlo definitivamente… Il fatto è che continua a vivere in noi, nel nostro sentirci eternamente schiavi, senza mai riuscire a diventare cittadini”. Il mito della Rivoluzione è ora appannato, quello di Stalin più vivo che mai: oggi rappresenta il culto della forza, la nostalgia dell’impero, la voglia di ordine e quella di farla pagare a qualcuno per ciò che è andato storto.
_________________________________________________________________________________
SCARICA L’ARTICOLO IN FORMATO PDF: