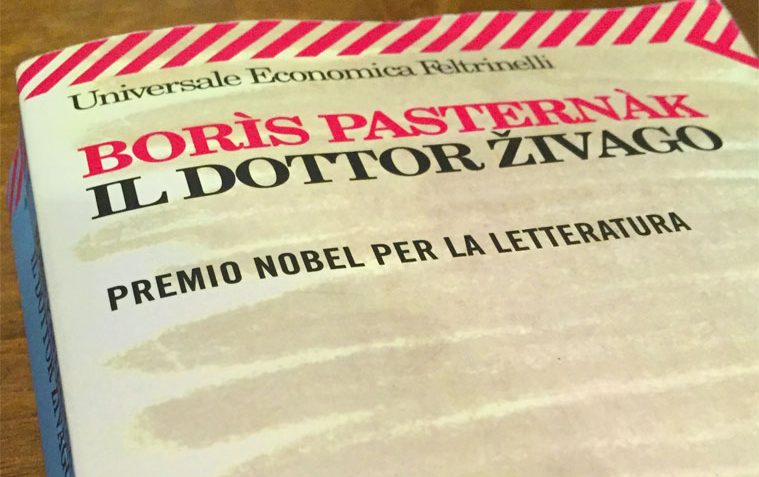In questi giorni numerosi articoli e trasmissioni ricordano la figura di Boris Pasternak, grande poeta russo scomparso il 30 maggio 1960. Il suo nome è legato al Dottor Zivago, romanzo che metteva in luce i lati oscuri della Rivoluzione d’ottobre. Incriminato dal regime sovietico che ne tentò il sequestro, il manoscritto riuscì a raggiungere clandestinamente l’Occidente dove fu pubblicato e ottenne nel 1958 il premio Nobel. Divenuto il simbolo della guerra fredda costò infinite persecuzioni al suo autore. L’apertura recente di nuovi archivi dei servizi segreti dell’epoca ha arricchito di ulteriori trame inquietanti i tentativi di delegittimazione dello scrittore e delle persone vicine, aprendo la strada a un nuovo filone di critica sull’argomento anche in italiano. A noi oggi resta la possibilità di leggere il romanzo come il racconto di una grande avventura puramente umana, fuori dagli scontri ideologici.
________________________________________________
IL CASO PASTERNAK
Che cosa è stato Il dottor Živago
Erica Klein
Erica Klein è laureata in Lingua e Letteratura Russa. Traduttrice dal russo di classici, saggista e autrice di numerosi lavori di critica letteraria. Docente presso la Scuola di specializzazione in psicoterapia del Ruolo Terapeutico.
Il nome di Boris Pasternak è legato a un grande romanzo russo del Novecento, Il dottor Živago, ma soprattutto alla polemica di dimensioni planetarie che, intorno a questo caso, si è scatenata quando, nel 1958, gli fu conferito il premio Nobel per la letteratura. Passioni incontrollate si coagularono intorno all’una o all’altra delle due grandi fazioni in cui era diviso allora il mondo. Il tema era scottante, minato all’origine, quello della rivoluzione del 1917, totem a cui, da sinistra, ci si poteva accostare solo in termini di devota reverenza. Pasternak fece diversamente, ne raccontò il risvolto antieroico, semplicemente umano, di chi si era trovato a convivere con un’epoca di violenti sussulti della Storia. Non gli fu perdonato. Le autorità sovietiche gli scatenarono contro una campagna di aggressione senza precedenti per quegli anni e gli negarono il visto per Stoccolma. Il premio fu ritirato 31 anni dopo, nel 1989, dal figlio Evgenij, quando l’URSS stava ormai collassando su se stessa. Pasternak visse altri due anni dopo l’assegnazione del Nobel, due anni che furono d’inferno, espulso dall’Unione degli scrittori, cioè dalla stessa identità di scrittore, diffamato, isolato, marchiato come il peggior nemico dell’URSS, della patria, del popolo russo.
Vale la pena parlarne oggi, a sessant’anni dalla sua morte, avvenuta il 30 maggio del 1960, anche perché ci dice qualcosa di noi, di quello ch’eravamo, che molti di noi erano, dello spirito del tempo che impediva di uscire dal bozzolo, di guardare a un romanzo per quello che era e non come al vessillo di una guerra di religione. L’Italia ebbe il primato della sua pubblicazione per l’ostinazione di Giangiacomo Feltrinelli, che lo volle a tutti i costi, battendo sui tempi Francia e Germania. Osò anche sfidare la censura sovietica e le sue propaggini occidentali, il Partito Comunista Italiano in primis, che nella persona di Togliatti fece pressioni d’ogni tipo sull’editore affinché il dattiloscritto, uscito clandestinamente dall’URSS, non vedesse la luce. Del resto gran parte del mondo intellettuale della sinistra europea, perfino Calvino, si schierò contro l’opportunità di diffondere un’opera con quelle caratteristiche, che sconfessava apertamente la facciata eroica della rivoluzione. Il romanzo naturalmente uscì, nel 1957, e il successo fu immenso in tutto il mondo, amplificato nel 1965 dal film di David Lean, con i due celebri protagonisti, Živago e Lara, impersonati da Omar Sharif e Julie Christie.
Che cosa pensare oggi di tutta quella vicenda? Al di là delle critiche propriamente letterarie che si possono fare alla struttura del romanzo o ai suoi personaggi più o meno riusciti, resta da chiedersi il senso di tale inaudita bagarre che percorse il mondo.
Penso che solo con un approccio di tipo psicologico si possa provare a decifrare qualcosa della possessione emotiva che teneva imprigionata, come in una faida, la mente di chi aveva optato in modo totalizzante per la fazione filosovietica della contesa. Occorre infatti aver presente la potenza simbolica di quell’evento del ’17, vissuto e tramandato come data sacrale di una nuova era nei rapporti umani. La rivoluzione fu vista come promessa realizzata di una palingenesi universale che l’umanità aspettava da tempo, non avendo più a disposizione redenzioni di tipo confessionale. Il cielo era vuoto. Nel mondo secolarizzato dell’Europa occidentale in preda all’angoscia nichilista, la filosofia aveva preso il posto della religione e il “sociale” quello della metafisica. I concetti di progresso, materialismo dialettico, sviluppo deterministico avevano assunto lo status di verità dogmatiche. Di esse si sognava e si viveva.
Ed ecco che dalla Russia arrivava un messaggio, la conferma che si era sulla strada giusta, che le ipotesi elaborate in un secolo di analisi teoriche erano fondate. Si poteva fare. Oltretutto sulla Russia si poteva proiettare qualunque cosa, era stata sempre, per l’Occidente, un regno lontano, coperto di nevi e di misteri, l’ideale per collocarvi la nascita di un mito. Scartato il vecchio Dio, un nuovo Assoluto era salito alla ribalta, carico di promesse e di certezze, la Storia. Non c’erano dubbi che operasse scientificamente, con una progressione razionale infallibile, e che decretasse quali popoli e quali classi fossero destinate a emergere e quali a scomparire. Per l’avanguardia del pensiero rivoluzionario russo, i bolscevichi, era arrivato il momento del proletariato; borghesia e capitalismo avevano i giorni contati, sarebbero stati espulsi dalla Storia. Era un assioma e i popoli facevano bene a prenderne atto. Una volta tanto toccava alla Russia segnare la direzione, fare da apripista e da modello della nuova epoca e dell’uomo nuovo, che si sarebbe prodotto semplicemente esponendolo a un ambiente rinnovato nei rapporti di classe. L’idea era semplice, elementare, perché elementare era la concezione che si aveva dell’uomo: una specie di tabula rasa su cui era possibile imprimere i valori desiderati, anche con la violenza, se necessario, ma valeva la pena, non ci sarebbe più stato l’uomo egoista, avido, invidioso e meschino generato dal capitalismo, al suo posto sarebbe comparso l’uomo collettivo, sociale, razionale. L’irrazionale infatti non esisteva, non era mai esistito, era una favola dei preti e di quel piccolo borghese di Freud che si era inventato l’inconscio per truffare i poveri di spirito. Per cambiare tutto bisognava partire dal pensiero dei singoli, che andava svuotato da ogni traccia di individualismo, categoria che, col nuovo corso, in una società paritaria, non avrebbe più avuto ragione d’essere. Il nuovo regime si sentiva depositario di una visione del mondo completa e universale, capace di rispondere a tutti i bisogni dell’umanità, materiali e spirituali, quasi un ordine monastico con una dottrina da far rispettare. Non era questo che il ceto colto si era prefigurato, quando con tutte le forze, si era speso perché la rivoluzione si realizzasse e portasse anche il popolo a partecipare alle conquiste dell’umanesimo. Fatalmente toccò ai russi portare il peso di questo programma rieducativo di perfezionamento della società, che avrebbe poi dovuto estendersi a tutta l’umanità. Da fuori, da lontano non si aveva idea di come la nuova fede impattasse sul corpo vivo della società e nemmeno c’era troppo interesse a saperlo, ci si accontentava dell’armatura concettuale con cui il programma veniva presentato. Ciò che importava all’estero era salvaguardare l’integrità del sogno, depurato da tutte le scorie della realtà, l’esperimento comunista si era realizzato e questo bastava. Un sogno che si trasformò in un incubo all’interno, per chi ebbe in sorte di doverlo tradurre in pratica: la vita privata di ognuno andò in frantumi, mentre una grande cultura e un’intera civiltà precipitavano nel baratro.
Occorre infatti ricordare che, quando i bolscevichi presero il potere, in quel 25 ottobre (7 novembre del calendario rivisto), la monarchia era già caduta, spazzata via dalla rivoluzione di febbraio, quella lungamente attesa e agognata ormai da tutti i ceti. Si era già instaurata una repubblica con un governo democratico che da un giorno all’altro aveva promulgato una serie di libertà che la Russia mai si era sognata di vedere: libertà di parola, di stampa, di associazione, di religione, suffragio universale, abolizione della pena di morte. Quella dell’ottobre, attuata da una minoranza radicale insoddisfatta della piega parlamentare presa dal governo, aveva chiuso con ogni ipotesi di democrazia formale e imposto qualcosa di sconosciuto fino allora, la dittatura del proletariato che doveva essere definitiva e perfetta. Ma, come si sa, la libertà è legata all’imperfezione, e così, per non disturbare l’utopia, si decretò la fine delle libertà appena conquistate, dei diritti civili, della proprietà privata, di qualunque libertà d’opinione, tutto controllato da una polizia segreta prontamente istituita. Fra i cittadini spettatori attoniti degli eventi c’era Boris Pasternak, che all’epoca aveva 27 anni, era già un poeta affermato, figlio della classe colta (il padre era un famoso pittore, la madre pianista). Di abbandonare la Russia, come capitò alla maggior parte degli intellettuali, non se la sentiva, il futuro che s’intravedeva era torbido. La sua vita da allora e per decenni corse su un doppio binario. Da un lato c’era la fatica di adattarsi a un mondo virtuale privo di fondamenta, tutto imperniato sull’ideologia, dall’altro c’era il bisogno di salvaguardare il proprio santuario interno, senza cui la vita avrebbe perso ogni senso.
A 55 anni, quando iniziò a scrivere il suo romanzo, ne sapeva abbastanza di materialismo dialettico, rieducazione delle coscienze, delazioni virtuose, e gli divenne chiaro che della sua vita personale voleva farne qualcosa. Naturalmente in segreto. Per tutto il periodo dell’URSS era impossibile dire la verità e sopravvivere, ma negli Anni Trenta del terrore staliniano era difficile sopravvivere comunque. Gli scrittori poi erano osservati speciali. Pasternak cercò di farsi dimenticare, occupandosi di traduzioni, Shakespeare, Goethe, Schiller, Rilke, Verlaine. Si mostrò anche molto coraggioso nel terribile 1937, quando rifiutò di porre la sua firma in fondo a una lettera che chiedeva la fucilazione di Tucha
evskij e di altri alti generali accusati ingiustamente di tradimento. Poteva costargli cara, ma ebbe fortuna, riuscì a salvare la dignità e anche la vita. Un vero miracolo. Stalin amava coinvolgere nei suoi delitti la coralità dei personaggi famosi, per dar l’idea, anche all’estero, di un’unità indissolubile fra lui e il suo popolo. È un mistero come Pasternak sia riuscito a restare vivo, mentre tutti intorno a lui scivolavano nel buio, compreso il suo vicino di da
a, Pil’njak, scrittore già ben noto. Sapeva di essere in pericolo per via della sua origine di tedesco del Volga, si aspettava di essere arrestato da un momento all’altro e proprio per questo scriveva fino all’ultimo. Pare che il bisogno di comunicare se stessi sia più forte di qualunque proibizione. Lui scriveva per il cassetto, anzi per la cassetta sottoterra. Ogni due pagine del suo romanzo Il granaio del sole andava a sotterrarlo in giardino. Non lo sapeva nessuno, nemmeno Pasternak con cui erano amici. Lo sapeva solo sua moglie Kira che, dopo la fucilazione del marito, fu arrestata a sua volta, ma tornò dal lager dopo dieci anni e andò a dissotterrare.
Tornando a Pasternak, forse Stalin l’aveva in simpatia, una volta nel 1934 gli telefonò perfino, per un’opinione a proposito del poeta Mandel’štam che fu poi comunque fucilato. L’arbitrarietà faceva parte dello stile del tiranno, che accarezzava in vario modo la propria onnipotenza, concedendosi anche i capricci degli dei. Pasternak cominciò a credere in una sorta di protezione interna che sentiva di avere e che gli permetteva a volte di osare l’inimmaginabile. Protezione che avrebbe poi esteso al suo personaggio, Jurij Andreevič Živago, vera controfigura della sua personalità, un dottore che doveva attraversare le intemperie della rivoluzione per arrivare là dove il destino aveva predisposto che arrivasse.
Il tema del destino è centrale in Pasternak, lo è sempre stato nella letteratura russa, a partire da Puškin, una fuga dalla Storia, una maniera diversa di ordinare gli eventi, di dar loro un senso finalistico, sottraendoli alla meccanicità del ciclo causa-effetto. Tutto è più ampio e misterioso di quello che appare e nemmeno si può escludere un fremito di magia nelle cose del mondo. Il 1945 era l’anno giusto per partire col romanzo e dar forma ai pensieri meditati nella solitudine di quei lunghi anni. Pasternak lo doveva a tutti gli scomparsi che non avevano potuto testimoniare l’epoca, alla sua missione di scrittore russo secondo tradizione che gli imponeva di ristabilire il vero, lo doveva ai suoi personaggi che vivevano dentro di lui già pronti da tempo e aspettavano solo di essere chiamati, prima che la grande Storia si chiudesse sulle loro piccole vite. La letteratura, a volte, come la psicoanalisi, si occupa delle cause perse, quelle tenute in nessun conto dai massimi sistemi. Živago, Lara, Tonja, Strel’nikov e tutti gli altri erano strutture del suo mondo interno che anelavano a essere rappresentate. L’anno giusto, dicevo, il 1945, fu un anno cruciale, euforico, nonostante gli enormi lutti e le distruzioni. Fu un anno speciale di rinascita, in cui sembrava che tutto fosse possibile, che la morte e la paura avessero abbandonato la Russia. La guerra era finita, il Paese si era sentito unito, solidale contro il nemico, questa volta esterno. Stalin, impegnato a vincere, aveva smesso di cercare nemici fra i suoi concittadini e alla fine la liberazione dal nazifascismo fu intesa da tutti, d’istinto, come la liberazione anche dall’oppressione interna. Se l’erano meritata i russi, avevano tenuto duro, patito, sconfitto i tedeschi, erano arrivati fino a Berlino. E poi, durante il periodo bellico c’erano stati segnali incoraggianti, i poeti più amati, quegli stessi che nel decennio precedente erano stati zittiti, proibiti, se non uccisi, erano tornati improvvisamente in auge, invitati perfino alla radio a recitare i loro versi. Bisognava tenere alto il morale delle truppe e nessun popolo ama la poesia quanto i russi. Al fronte i soldati recitavano i versi di Anna Achmatova come preghiere. Anche i religiosi ebbero vita più facile durante la guerra, molti furono richiamati dal lager per celebrare le funzioni e benedire i razzi Katjuša. Bisognava far leva sulle emozioni profonde del popolo e Stalin sapeva quello che faceva. Pasternak in quel 1945 si permise addirittura un incontro con uno straniero. Mossa azzardatissima, fino ad allora lo straniero, qualunque straniero, era considerato una spia e parlarci era punito con l’arresto. Lo straniero che si recò a incontrare Pasternak nella sua da
a di Peredelkino a trenta chilometri da Mosca era Isaiah Berlin, a quel tempo diplomatico dell’ambasciata britannica a Mosca, ma originario della Russia, da cui era fuggito bambino. Ore di conversazione notturne piene di pathos, di racconti, da anni Pasternak non parlava con un occidentale, lui che in gioventù aveva girato tutta Europa, studiato filosofia in Germania, ma ora si poteva di nuovo, o così almeno gli sembrava. Erano ufficialmente dalla stessa parte, avevano combattuto insieme contro Hitler, pensavano di averne diritto. Il dialogo fu intimo, confidenziale. Anche se alla fine risultò che Berlin non era riuscito a capire fino in fondo il senso di ciò che Pasternak raccontava. In Europa non si aveva idea del grado di surrealtà della vita sovietica, della catastrofe delle relazioni personali in quegli anni diventate insincere, stereotipate, pericolose, ogni parola imprudente buttata là poteva portare al lager. Pasternak, parlandone con uno straniero, si rese conto, forse per la prima volta in maniera così netta, dell’enormità di quello che era successo alla Russia. Il clima rilassato di quell’immediato dopoguerra aveva però i giorni contati, cambiò rapidamente, nuove minacce incombevano, la guerra fredda era alle porte e poi non era il caso che i russi si adagiassero troppo o facessero confronti con l’Occidente. Meglio chiudere tutto. C’erano i piani quinquennali da rispettare e se non funzionavano bisognava trovare i colpevoli. Da un giorno all’altro ripartirono le campagne di denigrazione contro questi e contro quelli. E chi meglio degli ebrei attirava da sempre le proiezioni negative del popolino? Solo che non li si poteva più chiamare ebrei, come sotto lo zar, bisognava dire più ufficialmente cosmopoliti. Partirono denunce a raffica contro medici, professionisti, incriminati per scarso patriottismo. Si tornò ai vecchi metodi, tanto più dolorosi, dopo i mesi di aperture. Pasternak provò a ignorare la paura, s’impose di farlo e si accorse di riuscirci, era stanco di finzioni, di maschere, di doppiezza, voleva tornare a essere libero, com’era stato in gioventù, e anche liberarsi dal senso di colpa. Tutta l’intelligencija russa che aveva sognato la rivoluzione come qualcosa di sublime e di immateriale, che avrebbe rimesso a posto le cose, era invasa da un senso di colpa opprimente. Tutti, in modo più o meno consapevole, sentivano di aver collaborato, per leggerezza, incoscienza, gioco della fantasia, alla disgrazia del loro paese, autorizzandone la distruzione. Il risveglio fu insopportabile, in alcuni prese la forma del suicidio come per Esenin, Majakovskij (la sua morte fu un trauma assoluto per Pasternak), Blok, già da prima si era lasciato morire d’inedia. Altri, come Bulgakov e appunto Pasternak provarono a curare la ferita scrivendo romanzi liberi, fuori dalle indicazioni del Partito. Quando la si ha la libertà, non ci si fa caso, ma appena la si perde, non si desidera altro nella vita. S’immerse totalmente nel romanzo, lì si sentiva libero. Partì da lontano per raccontare la sua storia, dai primi del Novecento, quando c’era lo zar stancamente autoritario, c’erano gli annosi problemi, le questioni maledette, la secolare ingiustizia, ma la vita era libera di correre, i sentimenti erano ammessi, le relazioni umane contemplavano anche la gentilezza, la simpatia, il rispetto, la generosità, la compassione, poi tutto finito, travolto dalla diffidenza reciproca, dall’ossessione di smascherare la natura classista dei comportamenti umani. Certo Jurij Živago, il protagonista era nato nella parte privilegiata della società, aveva avuto accesso al meglio, aveva studiato a Mosca, era diventato medico, professione che gli permetteva di essere utile in ogni tipo di situazione o regime. E invece no, con la rivoluzione si era trovato automaticamente fuori dalla società, ospite sgradito di un Paese che non lo voleva. L’equivoco di fondo era che la Russia non apparteneva più a chi non aveva origini proletarie. L’aveva occupata un’altra tribù che, per puro caso, parlava la stessa lingua. Ma Pasternak col suo romanzo non intendeva dire male della rivoluzione, né mettere sotto accusa ciò che n’era scaturito, non cercava polemiche, aveva una sua visione del mondo da esporre, che gli premeva dentro e che dava all’imprevisto e all’inaudito un posto di rispetto nelle cose umane. In un certo senso il libro si è scritto da solo, trasmesso da una necessità che una fonte spirituale s’incaricava di organizzare. Non è propriamente un romanzo filosofico, eppure lo è, perché il protagonista ha un suo modo filosofico, o meglio mistico, di analizzare il rapporto fra il suo Io profondo e il mondo esterno. Osserva non tanto gli eventi e le persone, ma le forze che li governano e li spingono. Di qui anche la sua maniera di vivere l’attività, sempre su un fondo di passività e con lo sguardo lontano, oltre l’oppressione dell’attualità. Il suo punto di riferimento non è la Storia, ma il Cosmo che consente all’individualità di esistere. È forse questo atteggiamento che ha fatto indignare le autorità, l’origine vera dello scandalo: “Ma come, hai avuto l’onore di partecipare al più grande avvenimento dell’Umanità e ci passi accanto indifferente, occupandoti dei fatti tuoi!”. Perché così è stato.
Il dottor Živago è una grande fiaba, una metafora dell’avventura umana, in cui l’eroe, seppure sbattuto da una parte e dall’altra, riesce a restare agganciato al proprio centro e ad andare incontro al proprio destino. Naturalmente all’inizio non sa quale sia, ma è fiducioso, sente di averne uno e che vale la pena scoprirlo. A indirizzarlo sono innumerevoli segnali sotto forma di coincidenze che costellano il suo percorso. È anche un romanzo d’amore, perché al fondo di tutto c’è lei, Lara, la controparte femminile della sua anima che lo segue ovunque, anche quando non si conoscono ancora. C’è un filo che, come un fiume carsico, entra ed esce dalla sua esistenza visibile, ma non l’abbandona mai, perché la segreta architettura del romanzo vuole così e organizza i loro incontri servendosi delle circostanze esterne. Jurij Živago sapeva già da bambino del lato imperituro nell’uomo, lo sapeva da quando era morta sua madre, lui aveva dieci anni, e l’aveva trasformata in protezione soprannaturale per non perderla. Del padre non aveva ricordi, se n’era andato presto, aveva avuto un’altra famiglia, in seguito a rovesci finanziari si era ucciso, eppure anche lui gli aveva lasciato un appiglio: il fratellastro Evgraf, più giovane di dieci anni, quasi sconosciuto e rimasto sempre nell’ombra sarebbe diventato l’aiutante magico nei momenti bui, quando la vita è in bilico. Jurij Andreevi
diventa ragazzo e poi uomo a Mosca in casa Gromeko, la famiglia adottiva, circondato da caldo affetto, dall’atmosfera di cultura e signorilità che regnava negli ambienti intellettuali della Mosca prerivoluzionaria. Gli anni erano scivolati via lisci e spensierati, sono gli ultimi di una Russia splendida, scintillante di carrozze, teatri, vetrine, eventi culturali nelle sue due capitali. Fuori, nei sobborghi rumoreggiano i diseredati, gli esclusi, le masse di operai. Si sognava la rivoluzione, non si credeva che potesse accadere.
Quel 27 dicembre 1911, festa dell’albero di Natale, una carrozza scivola sul ghiaccio duro e luccicante delle vie del centro. Tutto intorno è gelo. Jurij già medico siede accanto a Tonja, l’unica figlia dei Gromeko, la compagna allegra dell’infanzia, ma ora è diversa, fra loro è successo qualcosa che li rende emozionati. Stanno andando a un ricevimento. La festa, come sempre dagli Sventickij, fra danze, giochi, cena, durerà fino all’alba. Jurij alza lo sguardo, si accorge di un nero occhio formatosi nella crosta di ghiaccio di una finestra. Un occhio che lo guarda. “È una candela che arde sul tavolo” sussurra. Non sa che è un messaggio per lui. Dietro ci sono due ragazzi concitati, vengono da un’altra Mosca, quella dei cortili di periferia e vivono un dramma. Lei è Lara, giovane bellissima con la vita rovinata da un seduttore d’alto rango, compagno di sua madre, lui è Paša Antipov, figlio di ferroviere, innamorato di lei dall’infanzia, fino allo stordimento. Lara non gli dice nulla di quello che la turba e che ha in mente, gli annuncia solo di volerlo sposare al più presto, deve togliersi di dosso il senso di colpa, di vergogna, di sporcizia. Lui così pulito, candido, integro le sembra la soluzione alla disperazione. Ma prima c’è la vendetta da sistemare. Come folle si presenta in casa Sventickij quella famosa sera dell’albero di Natale, ha un conto da saldare e una pistola in mano. Spara al suo antico seduttore, sapeva di trovarlo lì, al tavolo da gioco. Trambusto, sconcerto, ma l’irreparabile non succede, lo colpisce solo di striscio e tutto viene messo a tacere per evitare lo scandalo. Živago non la perde un attimo di vista, la riconosce: di nuovo lei e in quali circostanze! E di nuovo quell’uomo dalle tempie grigie, ora sapeva chi era, il famoso avvocato Komarovskij, quello che aveva avuto a che fare con i rovesci finanziari di suo padre. Živago l’aveva già vista una volta quella ragazza, quand’era ancora studente, in un albergo di terz’ordine, dove una donna aveva tentato di avvelenarsi, era la madre di Lara. Živago era al seguito del professor Gromeko chiamato per l’urgenza. Lara era lì, abbandonata su una poltrona nella penombra, sfinita e, accanto a lei, quel tipo, l’avvocato, lo sguardo di lei sottomesso, ma anche una complicità impudica fra i due: la donna avvelenata era salva e loro non erano stati scoperti.
Poi più niente per anni. Intanto la vecchia vita di tutti era uscita dai binari della normalità, le storie personali sopraffatte dalle passioni civili, sociali, patriottiche. Era la prima guerra mondiale, quella foriera di tutti i deliri e le barbarie del Novecento. C’era un ministro dello zar, Nikolaj Durnovo, che lo aveva avvertito: la Russia non era in grado di sopportare una guerra. In un suo profetico memorandum del febbraio 1914 scriveva testualmente: “Tutto avrà inizio con l’accusa al governo di essere causa di ogni disastro. Si scatenerà una campagna antigovernativa seguita da agitazioni rivoluzionarie in tutto il Paese, ispirata a parole d’ordine capaci di sollevare e mobilitare le masse, dalla spartizione delle terre a quella di tutti i beni e patrimoni privati. Le istituzioni e i partiti saranno impotenti ad arginare la marea popolare e la Russia sprofonderà nella più disperata anarchia, con esiti che è impossibile prevedere”. Ed è ciò che puntualmente avvenne. Questo per la grande Storia, delle piccole storie intanto si occupava la corrente segreta degli avvenimenti. Lara e Živago vivevano lontani migliaia di chilometri e svolgevano al meglio le incombenze che la quotidianità assegnava loro di volta in volta e con ciò stesso aiutavano il futuro a farsi strada. S’incontrarono in Galizia, sul fronte di guerra. Živago la riconobbe per la terza volta, mentre lei ascoltava stupefatta quel testimone a un tempo familiare e sconosciuto del suo passato. Che n’era stato di loro in quegli anni? Lara e Paša si erano davvero sposati e avevano abbandonato Mosca per Jurjatin, città della Siberia da cui lei veniva. Era nata una bambina, Katja. L’apparenza della loro vita era buona, sotto la superficie covava l’infelicità, inspiegabile, indefinibile. Lui si era messo a studiare, si era laureato in filologia e in fisica, si era logorato con gli studi, ma non erano bastati a farlo sentire meglio, meno inadeguato, una depressione strisciante gli toglieva il sonno. L’attaccamento a lui di Lara era di natura diversa da quello che aveva sperato, non era amore, era un surrogato, un’attenzione affettuosa, materna che copriva qualcosa che non c’era e non poteva esserci. Del ragazzo semplice, ingenuo, non c’era più traccia. In una notte maturò la decisione per sottrarsi al malessere; arruolarsi volontario. Lara si disperò, pregò, ma non ci fu verso, lei non capiva, non sapeva, o forse sapeva. Arrivarono le prime lettere dal fronte, poi più nulla, corsero voci che fosse caduto prigioniero o addirittura ucciso. Lara, rosa dall’impazienza, seguì un breve corso di medicina per diventare infermiera e partì per il fronte alla ricerca del marito, dopo aver lasciato Katja da parenti. Del marito non riuscì a sapere nulla, trovò Živago mobilitato come medico dell’esercito su quel fronte. Anche lui si era sposato con Tonja, avevano un bambino, Šura, Alessandro. Nulla di esplicito accadde fra di loro, mentre lavoravano fianco a fianco nell’ospedale da campo, ma senza che ne avessero coscienza, tutto era rimandato, secondo il tratto di un disegno che li teneva d’occhio entrambi.
C’era aria di smobilitazione al fronte, era il momento in cui la guerra sfociava nella rivoluzione, una parola gioiosa che correva, inebriava tutti. “Intorno tutto fermentava, cresceva, saliva al magico lievito dell’esistenza. Il fervore della vita, come un vento silenzioso avanzava in una lunga ondata”. Pasternak presta a Živago la sua vena poetica, fa di lui un poeta, oltre che un medico. “La Russia, la nostra Russia si è mossa, non ce la faceva più a stare ferma, cammina e non si stanca di camminare, parla e non si stanca di parlare. E non è nemmeno che parlino solo gli uomini. Gli alberi, le stelle si sono incontrati e discorrono, i fiori notturni filosofeggiano e le case di pietra comiziano”. Tutto era meraviglioso: “La notte illuminata dalla luna era stupefacente come la misericordia o come il dono della chiaroveggenza”. Živago era felice di sentire che uomini, natura, cosmo erano riuniti in un unico grande abbraccio, era felice di chiudere con gli orrori della guerra, di tornare a casa da Tonja e dal bambino, di partecipare alla nuova vita tutta da costruire. C’era, è vero, la crocerossina Lara Antipov, così silenziosa, misteriosa, malinconica e c’era anche il suo sforzo per impedirsi di amarla, ma anche questo era felicità. Lara partì per prima, in ansia per la bambina. Živago si ritrovò mischiato a folle sterminate che assaltavano qualunque convoglio. Partivano tutti alla rinfusa, gente comune, soldati-contadini, per arrivare in tempo alla spartizione delle terre dei padroni, grande era il numero dei disertori, allettante lo slogan che correva per le truppe: “Espropriate gli espropriatori”. Nessuno voleva arrivare in ritardo, ognuno sognava qualcosa per sé. Masse di persone pernottavano per settimane nei prati intorno alla stazione, si spostavano come gigantesche onde compatte, appena sentivano lo sferragliare di un convoglio. Živago ebbe fortuna, riuscì a saltare su un treno, prima che lo stipasse la folla. Il viaggio era lungo, boschi, boschi e ancora boschi per arrivare a Mosca. Le cime degli alberi spuntavano dai finestrini e frusciavano sul tetto del treno, anche quando non li vedeva per l’eccessivo affollamento, Živago sentiva la loro presenza viva, ne aveva bisogno. La terra russa è una vastità così infinita da dare le vertigini. Induce alla riflessione, alla malinconia, alla pazienza, al fatalismo. Ogni russo lo sa. Si sente protetto, invincibile dall’immensità dello spazio che lo circonda, ma anche intrappolato nello stesso elemento che è la sua forza, spinto a divagare, a cercare nell’anima. Finalmente Mosca, la casa, la famiglia, l’abbraccio di Tonja. Dopo tre anni di guerra, dopo la rivoluzione, Mosca non aveva più nulla della città ch’era stata. Era buia, sporca, vuota, desolata, le botteghe chiuse, il commercio fuori legge, la moneta abolita e non si aveva idea di come procurarsi da vivere, una nuvola di ansia e di paura gravava sugli abitanti. Sui muri erano appesi sempre nuovi decreti su come comportarsi, chi denunciare. Gli appartamenti erano frazionati a ospitare numerose famiglie in coabitazione, i vecchi portieri, saliti di rango nella scala sociale, erano diventati potenti capi-caseggiato, toccava a loro informare le autorità sugli inquilini che mostravano scarso spirito collettivo. Živago era comprensivo: la massa del popolo aveva condotto per secoli un’esistenza inimmaginabile e le élites goduto di privilegi fuori misura. Era la resa dei conti, si capiva. Lavorava fino a notte all’ospedale, era comunque guardato male, faceva parte di quelli di prima e non riusciva a mantenere la famiglia. Racconta: “Sopravvenne l’inverno che si prevedeva. Ancora non spaventava tanto come i due inverni che lo seguirono, ma era già della stessa specie, buio, affamato, tutto impegnato a distruggere ciò che era abituale e a rifare tutte le fondamenta dell’esistenza. Furono tre quei terribili inverni, uno dopo l’altro e non tutto ciò che ora sembra avvenuto tra il 1917 e il 1918 successe in realtà allora, forse avvenne più tardi. Quegli inverni che si susseguirono sono fusi insieme e difficilmente distinguibili l’uno dall’altro. Dovunque si nominavano commissari con poteri illimitati, uomini dalla volontà di ferro, con neri giubbotti di cuoio, armati di misure di terrore, di rivoltelle Nagant, a caccia di piccoli borghesi”. Nel Paese regnava il terrore, in casa Živago la miseria. Tonja usciva comunque la mattina per andare “a caccia”. Vagava per i vicoli dove a volte passavano i contadini che portavano legumi e patate dai villaggi, in cambio di oggetti. Bisognava però saperli scovare, si nascondevano, quelli sorpresi con la roba venivano arrestati. Portavano anche mucchietti di rami. Li scambiarono di nascosto con un piccolo armadio a specchi. Sarebbe stato più ragionevole farlo a pezzi per ricavarne legna da ardere, ma non avevano il coraggio di farlo. Nell’ultimo di quegli inverni Živago si ammalò di tifo petecchiale, tutti erano a rischio, debilitati dalla malnutrizione, ma lui, a contatto con i malati, non riuscì a scamparla. Lo salvò il fratellastro Evgraf che spuntò dal nulla, con zucchero, riso, burro e altre meraviglie di cui non si aveva nemmeno più il ricordo. Prima di sparire gli consigliò di abbandonare la città, di nascondersi da qualche parte in campagna, vicino a un bosco, a un pezzo di terra da coltivare. Nell’aprile di quell’anno la famiglia Živago partì per gli Urali, alla volta di Varykino, piccolo villaggio dove i nonni di Tonja avevano avuto un’industria, la famosa industria Krueger. Chissà cos’era rimasto e di chi era ora, ma forse qualcuno avrebbe avuto pietà di loro e li avrebbe accolti in qualche modo. Di nuovo il treno. Con tutta la famiglia, c’era anche il padre di Tonja, la madre era morta anni prima, proprio quella sera dell’albero di Natale del 1911, e tanti fagotti. Un treno merci. “Viaggiavamo già da tre giorni, ma non ci eravamo allontanati molto da Mosca. Il paesaggio era invernale: i binari, la campagna, le foreste, i tetti dei villaggi, tutto era coperto di neve”. Gente che saliva, gente che scendeva, ma si facevano anche chiacchiere e perfino amicizie. Le lunghe ore vicini, i pasti improvvisati, ognuno offriva quello che aveva, si aprivano momenti di confidenza impensabili a Mosca. Si parlava liberamente perfino della rivoluzione. Il treno viaggiava nella natura e nella rivoluzione, passava attraverso villaggi distrutti, bruciati. Erano le bande armate della guerra civile, ora rosse, ora bianche, che si alternavano e gareggiavano in crudeltà. Ma c’era un nome che scivolava sussurrato con timore sulla bocca dei locali: Strel’nikov, un commissario di guerra che, dal suo treno blindato che correva avanti e indietro, ordinava incursioni e punizioni terribili. Živago ebbe la ventura di incontrarlo. Durante una delle interminabili soste del treno, per sfuggire alla calura, era sceso piano dal vagone, per non svegliare nessuno. Si ritrovò poco dopo con una canna di fucile puntata alla tempia. Era una delle sentinelle del commissario che dava la caccia a qualcuno, lo trascinò dal capo sul famoso treno. Gli comparve davanti un uomo giovane, d’aspetto piacevole, di modi educati, senza nulla che rimandasse alla sua fama di ferocia. Anzi, un certo fascino emanava dal suo viso chiaro e dai movimenti decisi, in tutto si avvertiva il dominio di una volontà di ferro che non lasciava nulla al caso, né al libero fluttuare della vita. Strel’nikov, dopo averlo studiato lo lasciò libero: “Scusate compagno Živago, c’è stato uno scambio di persona, non siete voi la persona che cercavamo – potete andare.” Però quel nome Živago gli ronzava nella testa. “È un nome di commercianti o di nobili. Oggi, egregio signore, sulla terra è il giorno del Giudizio, delle creature dell’Apocalisse. Ho il presentimento che ci rivedremo e allora, vi avviso, sarà tutto un altro discorso. Però ora siete libero, non mi rimangio la parola”. Il presentimento era fondato. Si sarebbero rivisti più avanti nella storia, ma non nel modo che immaginava Strel’nikov. A quel punto sarà
lui braccato, senza più strada davanti, né maschera sotto cui rifugiarsi e costretto a fare i conti con la sua nuda verità di uomo. Živago gli farà da testimone prezioso in una drammatica confessione-fiume ai confini del mondo. Strel’nikov altri non era che Paša Antipov, il marito di Lara che, diventando commissario, aveva cambiato nome. Caduto prigioniero in guerra, era poi fuggito e aveva trovato il suo posto di vendicatore nella furia della rivoluzione. Si era vendicato della sua semplice origine, della povertà della sua vita di bambino e adolescente, dei patimenti del padre imprigionato come operaio scioperante, della sua ingenuità, del sopruso fatto a Lara, di tutto il mondo della vecchia Russia che aveva fatto sì che la sua vita non fosse felice.
La natura che si risveglia in Siberia è una festa gigantesca, smonta la notte bianca dal nord e la terra riemerge dalla neve, i fiumi immensi si liberano dal ghiaccio e straripano, il verde si scatena. La Mosca cupa, gelida e incattivita è rimasta dietro anche nel ricordo, lontana migliaia di chilometri. Živago torna alla vita insieme alla natura. La sua anima ne prende nota. “All’inizio della notte si destò per una confusa sensazione di felicità, così forte da svegliarlo”. E poi c’era stata quella voce profonda di donna, anch’essa portata da un sogno, che non sapeva a chi attribuire. Finalmente Varykino, luogo sperduto oltre gli Urali, ci arrivarono da profughi, alla ricerca di un rifugio. L’accoglienza sulle prime non fu delle migliori, nessuno se l’aspettava e Tonja era la nipote dei vecchi proprietari delle officine Krueger, una nemica di classe, la riconobbero al volo ed erano tutti impacciati, se non dichiaratamente ostili e poi c’era il timore delle autorità, se fossero venute a sapere. Ma poi l’antica consuetudine all’accoglienza ebbe il sopravvento. Chi portava sementi di patate, chi legna da ardere, chi partecipava al rifacimento del tetto nelle due stanzette, un tempo adibite a dépendance per la servitù. Živago lavorava con gioia dall’alba al tramonto, a zappare, seminare, costruire, e ne provava un vero benessere. Ogni tanto faceva anche il medico, qualche contadino veniva a sapere che a Varykino si era stabilito un dottore e si trascinava per chilometri. Chi portava uova, chi una gallina, lui non avrebbe voluto nulla, ma la gente semplice non crede nell’efficacia dei consigli gratuiti. La sera, al lume di candela si leggevano ad alta voce i poemi di Puškin, o Guerra e pace. La vita aveva raggiunto una specie di normalità quasi bucolica, in armonia con la natura. In verità tutto quello che facevano era illegale, non erano registrati, occupavano terreno pubblico, si rifornivano di legna in un bosco pubblico. Ma la città con i suoi decreti e divieti era lontana e fin là non arrivavano gli echi di questi misfatti. Già, la città, Jurjatin. Quando a Varykino tutto fu a posto, riparato, seminato Živago cominciò a sentire la mancanza di libri, di studio, voleva sapere qualcosa della regione dov’era capitato, approfondirne la storia. Ci volevano tre, quattro ore per raggiungere la città a cavallo. I vicini gliene prestarono uno. L’atmosfera della biblioteca era sublime, pace, silenzio, parole appena sussurrate, montagne di libri a disposizione, un sogno dimenticato.
Di nuovo si fa vivo il Caso nel destino di Živago. Appena la vita esterna si rilassa e trova una sua forma di stabilità, ecco che dal profondo emerge il bisogno inquieto d’altro. Da fuori il Caso si presenta come aspetto enigmatico della realtà, combinazione di leggi diverse, da dentro come spinta a realizzare l’incompiuto della personalità. Siamo noi gli artefici del Caso? A produrre per via magica o inconscia le coincidenze? Freud rivendica la natura interna del destino, quella che ci rende lanterna del nostro stesso cammino. Come che sia è sempre un privilegio sentire di avere un destino, sapersi osservati da un’intelligenza cosmica che si coordina con la nostra storia personale. E qui c’è molto di Tolstoj, quello di Guerra e pace, della sua religiosità immanente che opera invisibile, ma indiscussa nelle vicende umane.
Lara. La vide in quella sala della biblioteca di Jurjatin, immersa nello studio (come insegnante si dava da fare per essere sempre aggiornata), frenò l’istinto a raggiungerla immediatamente, contò di farlo più tardi, quando si sarebbe calmato. Si seppellì nei libri, imponendosi di non alzare lo sguardo, quando se lo concesse, lei non c’era più. Dalla scheda lasciata alla restituzione libri lesse il suo indirizzo. La cercò dopo qualche tempo, in una ventosa giornata di marzo. Si ritrovarono, stettero insieme ore a rammentare, condividere, rivivere tutto quello che avevano passato in quegli anni densi come secoli compattati, in un’intimità sconosciuta, eppure sempre saputa e attesa. Questa volta era l’amore. “Ingannava Tonja e quello che le nascondeva era sempre più serio e più grave. Era inconcepibile. Amava Tonja fino alla venerazione. La pace della sua anima, la sua tranquillità gli erano più cari di ogni cosa al mondo. A casa, tra i familiari, si sentiva come un delinquente non ancora scoperto, il fatto che essi non sapessero nulla, la loro consueta affettuosità lo facevano star male”. Non riusciva a tenersi insieme, a sopportare la contraddizione, immaginava di raccontare tutto a Tonja e, per farsi perdonare, non rivedere più Lara, tornare a essere integro. Ma una volta raggiunta la decisione cambiava idea e rimandava tutto a un’altra volta. Ci pensò brutalmente il Caso, espressione ora del suo senso di colpa, a risolvere la questione, cavandolo d’impiccio. La sua vicenda personale fu risucchiata in quella ben più grande della Storia violenta del suo Paese. Anche la Siberia era diventata teatro di convulsioni. Una sera, mentre tornava a casa dalla città, tre cavalieri sbucati dal bosco lo bloccarono e lo costrinsero a seguirli. Erano bande rosse in cerca di un dottore da portarsi dietro nei loro agguati di guerriglia. Rimase con loro un anno e mezzo. La pace idilliaca di Varykino aveva comunque i giorni contati. La ferocia degli scontri stava per inghiottire nel sangue tutti gli abitanti delle campagne. Notizie terrificanti di massacri arrivavano a Živago. Ossessioni circa la sorte dei suoi. L’immaginazione correva e portava alla mente scene raccapriccianti di cui era stato testimone in quei mesi. Una notte di luna, in pieno inverno siberiano, decise improvvisamente di fuggire, dissotterrò le sue provviste e sugli sci lasciò l’accampamento, senza essere notato. Gli andò bene. Si trascinò vagabondo per giorni, camminando lungo la linea ferroviaria per non perdersi, sotto la neve, senza chiedere aiuto a nessuno. Le leggi della convivenza umana erano saltate e si viveva secondo quelle della giungla. Nessuno chiedeva aiuto a nessuno, tutti si temevano a vicenda, si uccideva per non venire uccisi. Più morto che vivo, barbuto, irriconoscibile, spaventoso, raggiunse la città, Jurjatin, doveva sapere dei suoi, che fine avevano fatto, forse qualcuno aveva notizie. E poi Lara, era ancora viva? Titubante e malfermo si trascinò fino alla casa di lei, dove era stato felice, non c’era nessuno. Prima di accasciarsi ebbe un lampo di genio, si ricordò del buco nel muro chiuso da un mattone, dove Lara nascondeva le chiavi. Miracolo! Non solo c’erano le chiavi, ma anche un biglietto per lui, nel caso fosse tornato mentre lei era al lavoro (Lara aveva saputo da conoscenti che era stato visto in giro per la città), con le notizie sulla sua famiglia, ch’era riuscita a mettersi in salvo e tornare a Mosca prima che il tornado travolgesse Varykino. Živago riuscì a malapena a entrare per accorgersi di non riuscire a reggersi in piedi, si lasciò andare, perdette i sensi, si addormentò. Si svegliò come in delirio, ignorava se fossero passate ore o giorni, gli parve di udire delle voci vicinissime ed ebbe paura che fossero i primi sintomi della pazzia. A un tratto si accorse che non stava vaneggiando, si trovava sdraiato non più sul divano, ma spogliato e lavato su un letto candido e qualcuno chino su di lui mischiava i suoi capelli con i propri, le lacrime con le sue, ed era tutto vero, c’era Lara. Si sentì venir meno per la beatitudine. C’era sempre un cielo che lo osservava e aveva in serbo per lui ancora una manciata di felicità. Anche se precaria e provvisoria, ma proprio per questo unica e preziosa. Lara lo curava e lo faceva lentamente tornare alla vita. Provarono a inserirsi nella vita di Jurjatin, Živago si dava da fare nell’ambulatorio della città, ma l’aria si faceva sempre più densa di inquietudini. Sia lui che Lara erano sulla lista nera dei prossimi arrestati, lui perché relitto di una classe superata, lei perché moglie di Strel’nikov, nel frattempo caduto in disgrazia. Decisero di fuggire, di sottrarsi alla vista, di guadagnarsi ancora un pezzetto di vita insieme. Con la piccola Katja partirono con una slitta trainata da un cavallo per Varykino, ormai abbandonata dalle bande rivali. Di nuovo Varykino la mitica, gruppuscolo di case solitario, perso nel deserto di neve, ultimo rifugio e anche ultimo pezzo di fiaba, quasi un piccolo presepe illuminato, senza possibilità di futuro, sospeso nell’aria tra l’oggi e l’eternità. Fecero di tutto per rendere splendente la loro capanna, calda, pulita, accogliente, ci lavorarono tutto il giorno. Spuntarono anche piccoli, inattesi regali, rarità d’altri tempi: fiammiferi, candele, sapone, oggetti di cancelleria lasciati da chissà chi, forse da un ufficiale zarista in fuga che aveva trovato lì un nascondiglio di passaggio. Ringraziarono commossi per il dono. Ultima delle meraviglie: una grande scrivania addossata alla finestra. Živago rimase inchiodato dallo stupore e dall’eccitazione. Erano anni che non sedeva a uno scrittoio a comporre. Attese la sera tardi, quando Lara e Katja dormivano, per godere di quella fortuna. Tutto era silenzio, fuori dalla finestra si stendeva l’azzurra, sontuosa, ghiacciata notte invernale. La luce gialla della lampada illuminava i fogli immacolati. Buttò giù di getto alcune strofe, poi il lavoro s’impossessò di lui in modo più profondo e avvertì l’avvicinarsi di ciò che chiamano ispirazione. “In quei momenti Jurij Andreevič sentiva che non era lui a compiere il lavoro essenziale, ma qualcosa di più grande di lui, lui era soltanto un’occasione, un punto d’appoggio, affinché la poesia potesse mettersi in movimento”. Alle tre di notte alzò gli occhi dalla scrivania e dalla concentrazione in cui era sprofondato, udì all’improvviso una nota triste e accorata uscire dal silenzio degli spazi lontani. Passò nella stanza vicina, buia, per guardare fuori: dapprima vide solo ombre sull’orlo della radura, al di là del burrone, poi, nettamente, la sagoma di quattro lupi coi musi puntati verso la casa. Era la fine, ecco cosa annunciavano i lupi. La forza ostile li aveva raggiunti. La lampada continuava ad ardere benevola, ma la magia era finita, non riuscì più a scrivere, né a pensare. Il tredicesimo giorno della loro permanenza a Varykino si portò via Lara. All’improvviso, dal lontano passato si fece vivo quell’avvocato, l’antico seduttore, Komarovskij, sempre lui, sempre aggiornato sugli eventi, emblema del tipo umano che traffica e galleggia in ogni regime e situazione. Propose a Lara e alla bambina una via di fuga in Estremo Oriente, su un treno speciale. Così, da un momento all’altro, malgrado le lacrime e le resistenze, Živago rimase senza Lara, intontito sui gradini d’ingresso a seguire la slitta che se ne andava, saliva e scendeva dai poggi, assecondando le curve, finché uscì del tutto dalla visuale. Živago sapeva che qualcosa doveva succedere, ma non voleva saperlo e non lo aspettava, non così presto, non così brusco. Il dolore prese la forma dell’ottundimento, una nebbia che gli impediva di tornare a se stesso, perché effettivamente lui non c’era più, c’erano pezzi staccati di lui che provavano a mettersi insieme per ragionare, senza riuscirci. Si accorse di uscire di senno lentamente, il giorno e la notte divennero indistinguibili, affastellati gli uni sugli altri in assoluto disordine. Ma qualcosa di sorprendente doveva ancora succede
re a Varykino. Una sera, prima del tramonto, Živago udì uno scricchiolio di passi sulla neve. Qualcuno si dirigeva verso la casa con passo deciso e da padrone. Pensò che fossero venuti ad arrestarlo. Si sbagliava. Gli si parò dinanzi il viso bello e vagamente noto di un uomo giovane, pescò nella memoria, era Strel’nikov, il marito di Lara. Da quando sapeva di essere braccato vagava da un nascondiglio all’altro e Varykino era uno di quelli. Ecco da dove arrivavano tutti quegli oggetti misteriosi. Il potere aveva una sua legge non scritta: far precipitare chi era salito troppo in alto. Inutile far valere i propri servigi alla Causa, vigeva una sorta di contrappasso spontaneo, chi troppo aveva infierito periva sulla scia dei propri eccessi. Ma chi era Strel’nikov? Uno come tanti, anche se più intelligente e più sensibile, uno che aveva creduto nella rivoluzione in modo totalizzante, come occasione di riscatto personale. Come tanti era rimasto intrappolato in una logica criminale che assolveva i propri delitti, se commessi in nome di un’entità superiore. Questa la novità dell’epoca: l’assassinio ideologico. Il dramma era che in una personalità originariamente non delinquenziale, questa postura doveva per forza scontrarsi con altre istanze presenti in lui, di natura contraria. Con quella del dubbio, innanzitutto, che, se accolto, rischiava di indebolire la grandiosità della Causa, per cui bisognava assolutamente impedirgli di salire alla coscienza. Avvertito come minaccia, come sintomo di disordine interiore, il dubbio andava prontamente coperto da un ordine esteriore, cioè da un fanatismo ancora più marcato. Fino alla rottura che prima o poi arrivava. Ma in genere provvedeva lo Stato a sanare il bisogno di punizione che gli individui stessi tacitamente invocano per porre fine alla lacerazione. Comunque Strel’nikov ebbe fortuna: trovò qualcuno disposto a fargli da confessore, una presenza familiare (amavano la stessa donna) che accolse il trauma della sua coscienza, senza interrompere e senza chiedere. Per ore, fino a notte fonda, andò in onda fra Strel’nikov e Živago il ristabilimento della verità, la fine di ogni menzogna, il ritorno al semplicemente umano. Giusto in tempo per morire risanato. La mattina seguente Živago lo trovò cadavere davanti alla porta di casa, si era sparato, prima di cadere nelle grinfie della polizia segreta.
C’è ormai poco da aggiungere anche per quanto riguarda Živago. La sua vita si fermò il giorno in cui perse Lara. Il resto fu sopravvivenza. Riuscì in qualche modo a tornare a Mosca da vagabondo e da vagabondo trascinò il tempo che gli restava, estraneo al mondo, chiuso in se stesso. La famiglia era approdata a Parigi, dove non gli era concesso raggiungerla. Il suo canto era finito. In un’afosa giornata di fine agosto, mentre viaggiava su un tram, fu colpito da infarto, come sua madre, riuscì a stento a scendere, per stramazzare al suolo poco dopo. Era il 1929 e non aveva ancora quarant’anni. Pasternak gli aveva risparmiato gli anni feroci dello stalinismo che ancora attendevano la Russia. Di lui restava il Canzoniere, scritto per Lara nelle gelide notti di Varykino, riunito e pubblicato da quello strenuo ammiratore della sua poesia ch’era sempre stato il misterioso e a quanto pare potente fratellastro Evgraf. Ultima coincidenza, ma le fiabe non danno spiegazioni logiche, al suo funerale fu presente Lara, capitata a Mosca chissà come, per puro caso e per un ultimo congedo, prima che la tempesta degli Anni Trenta la scaraventasse in uno dei tanti lager di cui era costellato il territorio sovietico.
Dei tanti romanzi sulla rivoluzione è l’unico rimasto nella memoria, depositato nella coscienza di ogni russo, vero romanzo cult e non solo per il chiasso ingiurioso provocato dal suo apparire, ma perché l’unico ad aver osato pensieri di verità, quando non erano ammessi. Il suo messaggio è uno solo: l’uomo non può dimettersi dal suo essere microcosmo irripetibile e gettare all’ammasso dell’omologazione forzata quanto lo rende unico, quali che siano le richieste dell’epoca. Ha un compito e un mandato; mettere a fuoco la propria umanità e trarne il meglio per sé e per gli altri. Non c’è altro da fare ed è l’unico modo per essere davvero vivi, cioè živi, come suona in russo, da cui Živago, il cognome scelto per il protagonista, affinché già nella sua radice lessicale fosse portatore di una visione e di una predestinazione.
_________________________________________________________________________________
SCARICA L’ARTICOLO IN FORMATO PDF: